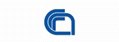“Dialoghi sul suolo e l’acqua” - Fra piogge torrenziali e lunghi periodi di siccità: la corretta gestione delle risorse idriche sarà una sfida da non perdere nel futuro
Dialogo con Paolo Mannini – Esperto di irrigazione, già Direttore scientifico e Direttore Generale del Canale Emiliano Romagnolo.
di Marcello Pagliai e Paolo Mannini
- 02 April 2025
Ultimi inserimenti
- Un podcast sull'agricoltura di oggi e domani, fra intelligenza artificiale e space farming
- Arboreto della Maremma e Hortus Maremmae Cistus
- I suini sanno cosa mangiare, se possono scegliere
- Foreste e gestione forestale: il ruolo dell'Unione Europea sotto i riflettori
- "The long and winding road" delle donne… E non solo nella scienza
Pagliai – La crisi climatica in atto ormai da decenni ci sottopone a imprevedibili e violenti nubifragi (come purtroppo accade ed è accaduto nei giorni scorsi in Toscana ed Emilia Romagna e già in passato, in questi dialoghi, ci siamo soffermati su queste tragiche situazioni – vedi, ad esempio, il dialogo del 7 febbraio 2024 “L’acqua: risorsa o calamità?”) e a certi periodi di siccità più o meno lunghi. In questa situazione è evidente che le piante hanno sempre più bisogno di acqua per assicurare livelli standard di produzione sia qualitativa che quantitativa. Visto che attualmente il 90% della pioggia che cade in maniera violenta la perdiamo per scorrimento superficiale e per allagamenti perché non si infiltra nel terreno, nel futuro, che potrebbe essere anche relativamente immediato, potremmo incorrere in una vera e propria crisi idrica. Cosa fare per contrastarla?
Mannini – Effettivamente la serie di periodi di grave siccità e di eventi alluvionali devastanti, come hanno riportato anche le cronache di questi giorni, si stanno alternando continuamente in molte parti di Italia. Non si può certamente dubitare che questi fenomeni siano le conseguenze del cambiamento climatico in atto; fenomeno che si pensava potesse essere lento e progressivo ma che, viceversa, si mostra sempre più incisivo e dannoso.
L’incremento delle temperature e la diminuzione delle piogge hanno già determinato un aumento dell’evapotraspirazione delle piante e quindi delle necessità idriche. La diminuzione delle “piogge utili”, cioè dei quantitativi di precipitazioni che riescono ad infiltrarsi nel terreno a vantaggio delle colture, aggrava il fenomeno rendendo sempre più necessaria l’irrigazione.
Si evidenzia che in alcune regioni italiane, nelle quali il ricorso all’irrigazione era, su alcune colture, raro ed effettuato con criteri “di soccorso”, oggi sia necessaria un’irrigazione stabile senza la quale le produzioni non riescono a determinare un reddito agricolo sufficiente.
La violenza e intensità delle precipitazioni non è l’unica causa dei fenomeni alluvionali ai quali stiamo continuamente assistendo. Infatti, la perdita di suolo e la sua impermeabilizzazione a causa della continua sottrazione di terreno agricolo per costruzioni e strade è continua. Il suolo così impermeabilizzato non consente l’infiltrazione dell’acqua aumentando i quantitativi idrici e riducendo i tempi del deflusso verso la rete di scolo e quindi verso i fiumi, esondando ed allagando il territorio. Per tali motivi si stanno finalmente iniziando in alcune città azioni di “depavimentazione”, cioè, riportando le superfici impermeabilizzate a superfici capaci di assorbire acqua piovana, abbinate ad un incremento delle alberature e dei giardini per ridurre le isole di calore cittadine. La costruzione di casse di espansione delle piene deve essere comunque implementata come elemento indispensabile di adattamento alla “tropicalizzazione” del clima.
La mancanza d’acqua necessaria per una ottimale pratica irrigua non può che essere effettuata mediante ovvie azioni. La prima è la costruzione di piccoli o grandi invasi di accumulo idrico, necessari per accumulare l’acqua nei periodi piovosi per il suo impiego in quelli siccitosi. Oggi solo un decimo dell’acqua di pioggia viene trattenuta in invasi sul territorio.
Anche il riuso irriguo delle acque reflue depurate è una delle possibilità alle quali si dovrà necessariamente far ricorso in alcuni territori, su alcune colture e con le dovute attenzioni per mantenere l’alta qualità delle nostre produzioni alimentari. In conseguenza della estrema siccità subita nel 2024 in alcune realtà siciliane si sta addirittura pensando all’uso di acque marine desalinizzate a fini irrigui.
Naturalmente, in tutti i casi, occorre ulteriormente procedere verso un uso parsimonioso e senza sprechi per ottenere le massime produzioni col minimo d’acqua. Oggi questa efficienza può essere ottenuta effettuando un’irrigazione di precisione attuabile col ricorso ai sensori, ai dati satellitari e all’intelligenza artificiale oggi disponibile. La ricerca scientifica in agricoltura deve essere sempre più centrale per il continuo miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua.
Pagliai – Le tecniche irrigue sono quelle che hanno beneficiato maggiormente delle innovazioni tecnologiche che hanno permesso, fra l’altro, lo sviluppo di nuovi sistemi di irrigazione. Quali sono gli approcci degli agricoltori.
Mannini – Per un’irrigazione efficiente anche la scelta e l’uso di metodi e sistemi irrigui di precisione può determinare un ridotto e corretto impiego dell’acqua. Oggi la possibilità di scelta dei sistemi irrigui si è notevolmente allargata: l’irrigazione per aspersione può essere effettuata con grandi macchine come quelli ad ali imperniate (pivot) anche dotati di spruzzatori portati vicini al suolo o tra le file della coltura per ridurre le perdite d’acqua. Con queste macchine è anche possibile la “irrigazione a rateo variabile” di alta efficienza perché differenziata nelle varie porzioni dell’appezzamento in base alle specifiche esigenze della coltura.
Nell’irrigazione a goccia gli erogatori sono ormai di alta qualità e anche auto compensanti, capaci di erogare la medesima quantità d’acqua anche in campi molto lunghi o declivi. Le ali gocciolanti hanno quindi allargato l’uso della goccia dalle colture frutticole ed ortive anche a quelle di pieno campo, sia mediante la loro stesura annuale tra le file della coltura, sia in subirrigazione con ali gocciolanti interrate fisse.
Le statistiche hanno evidenziato un sempre maggiore ricorso all’irrigazione a goccia da parte degli agricoltori. La scelta è in gran parte stata fatta per motivi di semplicità e comodità dell’irrigazione a goccia rispetto a quella per aspersione con ali mobili o semoventi (rotoloni) durante la stagione estiva. Nelle aziende agricole di grandi dimensioni l’irrigazione per aspersione con i Pivot è invece dominante, anche in questo caso per motivi di comodità e bassa esigenza di manodopera.
Occorre però ricordare che il sistema impiegato può influire sul risparmio idrico, ma la vera differenza è data dall’impiego corretto delle attrezzature irrigue che deve essere basato sulle effettive esigenze agronomiche ed economiche della coltura. In taluni casi, infatti, è stato verificato che la comodità del sistema irriguo stimola ad un maggiore impiego d’acqua, mentre i sistemi irrigui che richiedono molta manodopera per ogni intervento irriguo portano ad una riduzione del numero di irrigazioni, e quindi del volume stagionale d’acqua impiegata.
I sistemi di supporto alle decisioni irrigue oggi disponibili sono in grado di ridurre l’uso dell’acqua ma ci sono ampi spazi di miglioramento; la ricerca scientifica deve proseguire per ulteriori miglioramenti
Pagliai – L’agricoltura del futuro deve essere assolutamente “sostenibile” con un ritorno quindi alle “buone pratiche agricole” ormai ben note e proprio per questo lo sviluppo futuro è rappresentato proprio dall’introduzione delle innovazioni già disponibili in larga parte, come l’agricoltura di precisione, ma la loro applicazione trova spesso delle criticità. Ad esempio, pensando alle connessioni digitali non si può non accennare che in vaste aree del nostro territorio sono ancora carenti. Quali sono le prospettive?
Mannini – Come già evidenziato sono già presenti i primordi di alcune innovazioni permesse dalle migliori conoscenze scientifiche e tecnologiche conseguite, come l’irrigazione a rateo variabile, l’uso di sensori di umidità del suolo o di stress idrico della coltura, l’impiego di dati satellitari, l’intelligenza artificiale, ecc. Queste innovazioni devono passare sempre più dai laboratori al campo; processo che può essere conseguito semplificando le applicazioni per gli agricoltori e stimolandone l’uso mediante incentivi economici al loro impiego.
Probabilmente l’impiego delle innovazioni presenti e future sarà maggiore nelle aziende di grandi dimensioni e su colture dove l’impiego di nuove tecnologie, guidate da pochi tecnici agricoli esperti, riusciranno a migliorare l’uso dell’acqua e le produzioni nonostante la progressiva mancanza di manodopera agricola disponibile.