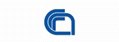"The long and winding road" delle donne… E non solo nella scienza
di Amedeo Alpi
- 02 April 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
Ho finito di leggere un ottimo testo sulla situazione delle donne in scienza. L'argomento è di quelli seri, che richiedono soluzioni, mentre mi ricordo bene che il mio personale tragitto su questo tema è stato, nel tempo, se non proprio tortuoso, almeno titubante. Eppure, vissi, in un campus universitario americano degli anni '70-'71 del secolo scorso, l'esordio di un movimento femminile di massa che poneva il problema dell'emarginazione della donna -nella società e quindi anche nella scienza- in modo deciso; ma, pur riconoscendo la legittimità di quelle richieste, rimasi per anni in una sorta di limbo. Ero attirato da quel movimento, ma rimanevo incerto (il mio valore primo era il merito); tornato in Italia, dopo qualche anno divenni un assiduo lettore del quotidiano "la Repubblica" e mi capitò di leggere un editoriale del suo direttore, Eugenio Scalfari, nel quale, a commento dell'ormai cresciuto movimento femminista, dichiarava che non c'era stato nulla, negli ultimi anni della nostra storia collettiva, più significativo del movimento di emancipazione della donna. Da quel momento divenni sempre più attento a quanto emergeva da questa parte della società che comprendeva peraltro moglie e figlia nel frattempo cresciuta.
Il volume che vi ho citato all'inizio è "La scienza al femminile", libro multiautore, curato da Maria Pia Abbracchio e Giacomo Lorenzini (quest'ultimo nostro Accademico Emerito) e edito nel 2025 da Franco Angeli. Già nella Prefazione, Adriana Albini, rilevando che, sebbene in gran parte dei Paesi OCSE le donne superino gli uomini nel conseguimento di titoli di studio universitari, continua a persistere un divario significativo nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); ancora nel 2024 le donne laureate in questo ambito non superavano il 35% del totale. D'altra parte, dalla statistica del mondo globale emerge che solo il 30% dei ricercatori sono donne e importante conferma di tutto questo emerge dal Premio Nobel (istituito nel 1901) per le materie scientifiche: mentre 550 sono stati i riconoscimenti ricevuti da uomini, solo 18 sono stati assegnati a donne. Sulla base di questi dati, Rita Levi Montalcini dichiarava che il cervello femminile non è inadeguato agli studi scientifici e che la differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale; si tratta solo che lo sviluppo cerebrale nella donna è stato storicamente represso, mentre nell'uomo è stato incoraggiato.
Nell'articolo scritto dalla Abbracchio è delineato molto bene il percorso storico femminile nella scienza che è iniziato senza che le donne si preoccupassero di un riconoscimento personale del lavoro svolto. Oggi la situazione è molto cambiata, ma occorre vigilare perché i diritti non sono mai acquisiti per sempre e, troppo spesso, il primo diritto a essere negato alle donne è l'accesso all'istruzione. D'altra parte, per troppo tempo le donne coinvolte nella ricerca si sono accontentate di ruoli ancillari al fianco di scienziati maschi che divenivano -e talora la situazione persiste- i "proprietari" delle scoperte. La comunità scientifica internazionale conosce il caso di Rosalind Franklin, alla quale non fu assegnato il Nobel nel 1962 per la scoperta della struttura del DNA, nonostante che per prima avesse fotografato la struttura a doppia elica del DNA lavorando con Wilkins al King's College di Londra, mentre il premio fu ricevuto da Watson, Crick e Wilkins che mai riconobbero ufficialmente il fondamentale contributo di Rosalind. Passando al caso Italia, la Abbracchio, molto opportunamente, osserva che nell'ultimo Global Gender Gap Report del 2024, che valuta come i vari Paesi si muovano sulla parità di genere, nei primi 10 posti ci siano ben sei Paesi europei, ma l'Italia è all'87° posto della classifica arretrando di ben 8 posizioni rispetto all'anno 2023! Tutto questo nonostante che la nostra Costituzione sancisca la parità di genere. In questo senso molto incisiva è l'affermazione, a proposito del periodo della pandemia da Covid-19, che "oltre a perdere terreno sull'eguaglianza al posto di lavoro, le donne hanno sofferto di un enorme sovraccarico di extra lavoro a casa". Facendo ricorso al linguaggio sintetico, ma realistico, dei numeri: su 672 miliardi di ore di impegno non pagato per la cura e la sorveglianza dei bambini (ma anche degli anziani), le donne si sono dovute assumere almeno 512 miliardi di questa quota di lavoro aggiuntivo non pagato. Quindi quella per i diritti delle donne è una lotta per la libertà e la democrazia per tutti.
Quasi a chiusura del volume c'è l'articolo di Giacomo Lorenzini su Rachel Carson; la scrittura di Lorenzini è un esempio di professionalità. Non ho letto molto sulla Carson, ma posso dire che è raro trovare un articolo così ben documentato. Anche in questo caso devo riaffermare che, personalmente, ho avuto un percorso assai sinuoso tra lo scetticismo e una attenzione crescente verso la Carson. D'altra parte ciascuno di noi si porta dietro le proprie esperienze e non nascondo che quando nel campus della Michigan State University, nei primissimi anni '70 già citati poco sopra, ascoltai, in una enorme sala gremitissima, il Premio Nobel per la Pace Norman Borlaug fare una battuta ironica sulla difficoltà di riscontrare una "primavera silenziosa", nelle varie campagne americane dove effettuava le sue esperienze di genetica dei cereali -e che portarono alla "green revolution"-, rimasi assai colpito. Ma, credo con il mio amico Giacomo, che, come accadde con la Capanna dello zio Tom, così fu per Silent Spring, una sorta di mutazione per cui quello che c'era prima fu sostituito definitivamente da un nuovo paradigma: l'elegantissima società tecnologica che si era affermata sino a quel momento doveva cedere il passo alle robuste conoscenze ecologiche che stavano crescendo, per non correre il rischio di nuocere all'intera umanità.
Il nostro mondo si muove in mezzo a mille contraddizioni; mi piace a questo proposito ricordare quanto scritto in una nota dell'articolo di Lorenzini: la Carson muore nel 1964 a 56 anni, ma la mattina del suo funerale non si poteva arrivare in auto presso la National Cathedral di Washington perché era in corso un trattamento insetticida agli alberi. Come l'ha definita Giacomo Lorenzini "Un'ultima beffa del destino"!
Comunque, dati alla mano, il direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, dell'Università di Pisa, prof.sa Cristina Nali conclude, nella Premessa al testo, che "...il futuro tende al rosa, era l'ora".
Siamo d'accordo con lei, certamente con l'ottimismo della volontà, ma anche con l'ottimismo dell'intelligenza.
Foto: Rachel Carson (per approfondimento si legga l’articolo: Rachel Carson (1907-1962), la biologa americana che ci ha fatto capire per sempre il modo in cui l’umanità deve confrontarsi con il mondo naturale)