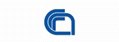Dialoghi sulle biotecnologie: “Il contributo delle TEA per il Miglioramento genetico della canapa”
Dialogo con Paolo Ranalli, già Direttore di dipartimento dell’ex-CRA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura), ora CREA.
di Luigi Frusciante e Paolo Ranalli
- 16 April 2025
Ultimi inserimenti
- Dalla cucina paleolitica alla postcucina
- Limiti normativi alla valorizzazione degli scarti per l’agricoltura
- Sei mesi per cambiare il mondo?
- Eunice Newton Foote (1819-1888): la scienziata che aveva previsto il cambiamento climatico, ma non fu creduta, in quanto donna
- Dialoghi sulle biotecnologie: “Il contributo delle TEA per il Miglioramento genetico della canapa”
Frusciante: Le colture industriali si dividono in due settori: agroalimentare (food) e non alimentare (no food). Paolo, con te vorrei approfondire due delle specie più rappresentative di queste categorie: la canapa e la barbabietola da zucchero. Iniziamo dalla canapa. Sappiamo che questa pianta produce molteplici metaboliti con effetti benefici sulla salute e altri con proprietà psicotrope che ne limitano l’impiego agricolo. Sappiamo anche, che è in vigore una normativa specifica che ne regolamenta la coltivazione per usi agricoli.
Ranalli: La canapa contiene due principi attivi di particolare rilevanza: il cannabidiolo (CBD) e il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). Questi composti sono simili agli endocannabinoidi, sostanze prodotte naturalmente dal nostro organismo, che interagiscono con recettori presenti nel cervello e nelle parti periferiche del corpo. Il THC si lega principalmente ai recettori delle cellule nervose ed esercita effetti psicoattivi, mentre il CBD agisce sui sistemi periferici, non ha effetti psicotropi e può contribuire al trattamento di diverse patologie, tra cui ansia, convulsioni, infiammazioni e spasmi. A seconda dell’impiego, le varietà destinate all’uso agricolo devono contenere quantità minime di THC (inferiori allo 0,2%), mentre quelle per scopi farmacologici devono presentare un’elevata concentrazione di CBD. La normativa di riferimento è la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, volta a promuovere la filiera agroindustriale della Cannabis sativa L. La legge stabilisce che la coltivazione è consentita esclusivamente con sementi certificate di varietà iscritte nel Catalogo comune dell’Unione Europea. Gli impieghi della canapa coltivata includono la produzione di alimenti e cosmetici, semilavorati industriali, materiali per la bioedilizia, fitodepurazione, nonché attività didattiche e di ricerca. Inoltre, la canapa rientra tra le colture ammesse ai finanziamenti della Politica Agricola Comune, ma per la sua coltivazione è necessario possedere una partita IVA agricola. È importante sottolineare che il quadro normativo è in continua evoluzione: attualmente è in fase di esame un disegno di legge che potrebbe rendere più flessibile il limite di THC consentito.
Frusciante: Nonostante i numerosi benefici della coltivazione della canapa, questa filiera agroindustriale fatica ad affermarsi. La canapa migliora la struttura del suolo, favorendone l’aerazione e la fertilità, e contribuisce alla riduzione dell’uso di erbicidi chimici grazie alla sua crescita rapida e vigorosa, che soffoca naturalmente le malerbe. Tuttavia, diversi fattori ne ostacolano la diffusione. Quali sono le principali cause di queste difficoltà?
Ranalli: L’interesse per la canapa industriale è in crescita, grazie alla crescente consapevolezza dei suoi benefici ambientali ed economici. Tuttavia, la sua coltivazione è ancora limitata per diverse ragioni. Innanzitutto, la canapa è stata a lungo associata alla cannabis psicoattiva, creando una percezione negativa che ne ha ostacolato la diffusione. Inoltre, la necessità di permessi e licenze, unita ai rigorosi controlli sul contenuto di THC, tende a scoraggiare molti agricoltori. Un’altra difficoltà è rappresentata dalla raccolta: sebbene esistano alcuni prototipi di macchine per la canapa da fibra, la mancanza di cantieri di raccolta adeguati complica ulteriormente il processo produttivo. Uno degli ostacoli principali riguarda la trasformazione della canapa in prodotti finiti. Questa fase richiede infrastrutture specifiche, come impianti per la lavorazione delle fibre e per l’estrazione dell’olio, che in Italia sono ancora poco diffusi. A differenza della Francia, in Italia mancano impianti per la prima lavorazione della canapa. Il mercato dei semi alimentari è ben sviluppato nel Nord Europa, ma le industrie italiane si riforniscono ancora dall'estero. Anche l'industria della fibra, pur avendo potenzialità, non ha ancora raggiunto un livello tale da giustificare un aumento significativo delle coltivazioni.
Frusciante: L'ex ISCI di Bologna, oggi CREA-CI, è un centro di ricerca di riferimento per la canapa e per lo sviluppo di nuove conoscenze genetiche su questa coltura. Quali sono i principali filoni di ricerca genetica su cui è attualmente impegnato? A che punto siamo nella comprensione delle basi genetico-molecolari di questa pianta?
Ranalli: Il CREA-CI, è fortemente impegnato nel miglioramento genetico della canapa per uso tessile. Ha recuperato storiche varietà italiane di canapa tessile, come Carmagnola e Fibranova, e ha realizzato un programma di mutagenesi per indurre mutazioni associate al chemotipo da fibra. Questo aspetto è cruciale, poiché le varietà da fibra sono spesso confuse con quelle a uso psicotropo basandosi unicamente sul fenotipo. Grazie a questo programma, è stata selezionata la varietà Red Petiol, oggi rinominata Fibrante, caratterizzata dalla colorazione violacea del picciolo fogliare e da un basso contenuto di THC. Gli studi sulla variabilità genetica hanno portato all’identificazione di un gran numero di SNP, microsatelliti e altri marcatori molecolari, strumenti fondamentali per i programmi di selezione assistita. Questi marcatori hanno consentito il rilascio di numerose varietà sia da fibra sia a uso farmaceutico, con un elevato contenuto di CBD.
L’uso massiccio di SNP ha permesso di distinguere, a livello genomico, i due principali gruppi di Cannabis sativa, quello da fibra e quello a uso psicotropo, e di sviluppare un sistema di fingerprinting genetico per attribuire un profilo molecolare univoco a ciascuna varietà. Il sequenziamento del genoma della canapa, pubblicato nel 2011, ha consentito l’identificazione dei geni responsabili della sintesi dei cannabinoidi, tra cui il THCA sintasi (che regola la produzione di THC) e il CBDA sintasi (coinvolto nella sintesi del CBD). Studi più recenti hanno affinato la conoscenza della struttura genetica della C. sativa, creando mappe dettagliate dei cromosomi e localizzando con precisione i geni di interesse agroindustriale. Inoltre, il centro di Bologna ha sviluppato protocolli consolidati per la rigenerazione da callo e trasformazione genetica. Questi strumenti rendono possibile l’applicazione delle Tecniche di Evoluzione Assistita, con cui è possibile modificare selettivamente i geni coinvolti nella sintesi dei cannabinoidi, ottimizzando la produzione di CBD o THC e modulando il rapporto tra di essi a seconda delle necessità applicative.