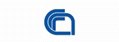Opportunità e problematiche per la viticoltura eroica
di Paolo Storchi
- 19 February 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
La presenza della vite è diffusa su un ampio areale, che nell’emisfero nord va da 30° a 50° di latitudine. In molti di questi territori, la coltivazione avviene storicamente in vari ambienti considerati “difficili”, quali le zone ad elevata pendenza o montane.
Le problematiche di gestione dei vigneti in queste aree sono comuni a molti territori italiani, tanto che nel 2020, su sollecitazione del CERVIM (organismo internazionale creato nel 1987 sotto gli auspici dell’O.I.V.) è stato emanato un Decreto interministeriale che definisce questa tipologia di viticoltura, definendola “eroica”. Il D.M. 30.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2020 riporta all’art. 3 i requisiti per la definizione di viticoltura “eroica”, cioè:
- coltivazione su terrazzi e gradoni;
- altitudine superiore a 500 m (esclusi gli altipiani);
- pendenza superiore al 30%;
- vigneti nelle piccole isole;
Le caratteristiche che accomunano le zone sulle quali si fonda il riconoscimento delle "viticolture eroiche" sono di fatto le seguenti:
• condizioni orografiche che creano impedimenti alla meccanizzazione;
• vigneti dalle ridotte dimensioni, non sempre contigui e in molti casi con presenza di terrazzamenti o significativi dislivelli tra i filari;
• aziende agricole con superfici aziendali contenute e prevalenza di imprenditorialità non a titolo principale;
• condizioni climatiche talvolta limitanti;
• tipologie produttive spesso fuori dai modelli di riferimento (prodotti di nicchia);
• vigneti situati in aree geografiche ad alta valenza paesaggistica e turistica.
Con il termine di viticoltura eroica si riuniscono quindi diverse tipologie di viticoltura, con problematiche comuni ma anche differenti esigenze e problematiche, ad esempio nei riguardi dei cambiamenti climatici che, se da un lato rendono più difficile la coltivazione nelle piccole isole o nelle zone a minore altitudine, dall’altro ampliano l’areale di coltivazione alle zone di montagna e permettono ormai di arrivare ai 1.000 metri nell’Appennino.
Nelle piccole isole le difficoltà di coltivazione sono evidenti e la riduzione delle superfici coltivate è stata marcata negli ultimi decenni. All’Isola d’Elba, ad esempio, dal 1980 ad oggi la superficie è passata da oltre 1.000 ha a meno di 200.
Se negli ambienti insulari il cambiamento climatico contribuisce in modo significativo ad aumentare le difficoltà di coltivazione, il riscaldamento è invece uno dei fattori che sta portando a rivalutare la viticoltura di montagna. Le sempre più frequenti ondate di calore e l’aumento termico registrato negli ultimi anni in tanti ambienti di pianura e collina stanno infatti portando ad uno squilibrio nella maturazione dell’uva, ad esempio disaccoppiando la maturazione zuccherina da quella fenolica, per cui uno dei rimedi è costituito proprio dallo spostamento in altitudine dei nuovi impianti, dove possono essere mitigati gli effetti dell’innalzamento delle temperature.
Con l’aumento dell’altitudine si registrano minori sommatorie termiche nel ciclo vegetativo (con il rischio di una minore induzione a fiore) e maggiori escursioni termiche tra giorno e notte in maturazione, che possono favorire una maggiore presenza di composti aromatici nell’uva. Aumenta anche il rischio di eventi dannosi, quali la grandine.
I vigneti a maggiore altitudine o elevata pendenza presentano elevati costi di gestione, in particolare per la difficoltà di impiegare le macchine dovuta alle piccole dimensioni degli appezzamenti. Anche in queste situazioni l’introduzione della meccanizzazione può comunque incrementare enormemente la capacità di lavoro e di ottimizzazione delle diverse operazioni colturali.
Nei sistemi montani vulnerabili i processi di abbandono nei decenni scorsi hanno causato varie problematiche relative alla stabilità dei versanti. Del resto in molti ambienti il lavoro dell’uomo ha contribuito nel tempo a costruire un paesaggio unico caratterizzato da terrazzamenti, muri a secco, alternanza di terreni coltivati con prati o zone boscose, creando un paesaggio agrario molteplice sia nelle forme che nella composizione, fortemente parcellizzato e interconnesso, caratterizzato da appezzamenti vitati intervallati da un’importante presenza di elementi naturali che funzionano da efficace rete ecologica, in grado di fornire servizi ecosistemici di qualità.
Questa tipologia di viticoltura rappresenta comunque una percentuale minima della produzione e superficie nazionale. È quindi di limitato interesse dal punto di vista macroeconomico, ma importantissima dal punto di vista socioculturale e microeconomico. Anche per questi motivi sarebbe opportuno prevedere adeguati sostegni e incentivi alla coltivazione dei vigneti.
Se la viticoltura eroica presenta indubbi punti di debolezza, quali costi elevati di produzione, ridotte dimensioni aziendali e dei vigneti, condizioni climatiche spesso limitanti, sono da evidenziare anche alcuni potenziali punti di forza, quali la tipicità delle produzioni ed il legame con il territorio, la valorizzazione complessiva dei prodotti agroalimentari, il mantenimento dei terreni coltivati o il recupero di aree abbandonate soggette a rischi idrogeologici.
Un aspetto da tenere presente nella viticoltura eroica è relativo al fatto che la maggior parte degli operatori non esercita l’attività agricola come attività principale, ed in generale l’età media è molto elevata, anche se si registra negli ultimi tempi una maggiore presenza di giovani imprenditori. Dal punto di vista economico si evidenzia la presenza di due tipologie principali di produttori, una costituita da microaziende familiari a conduzione part-time o hobbistica, l’altra da piccole aziende strutturate, rivolte al mercato, spesso con giovani imprenditori orientata all’innovazione e con ambizioni di ampliamento. È questa la categoria più aperta alla condivisione di mezzi, attrezzature e marketing, così come si avvantaggia del fenomeno relativo all’enoturismo.
Nella viticoltura eroica sono specifiche, e spesso diverse rispetto alla collina e alla pianura, le esigenze agronomiche, dalla gestione del suolo alle forme di allevamento, e ancora prima in relazione alle scelte varietali. Per la gestione dei vigneti la recente diffusione delle tecnologie di agricoltura di precisione, in particolare dei DSS per i modelli previsionali delle malattie e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto, possono aprire nuove opportunità non solo per il monitoraggio dello stato vegetative delle piante, ma anche per la gestione delle principali pratiche agricole.
In conclusione, la viticoltura di montagna può rappresentare una risposta innovativa e coraggiosa alle sfide poste dal cambiamento climatico e i vini prodotti in alta quota, con la loro freschezza, complessità e caratteristiche distintive, possono intercettare i gusti e le nuove tendenze dei giovani consumatori.