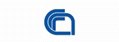L’antico fenomeno delle droghe indigene europee
di Giovanni Ballarini
- 12 February 2025
Quando si parla di droga leggera si pensa a una sostanza psicotropa in grado di indurre dipendenza e nella maggior parte dei casi ci si riferisce alla marijuana ottenuta dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di cannabis (Cannabis sativa) e a un fenomeno recente se non recentissimo. Niente di più sbagliato perché l’uso psicoattivo di questa pianta è un fenomeno antichissimo iniziato nella Siberia meridionale, diffusasi in Asia centrale e giunta nelle Americhe dopo Colombo, anche se residui di cannabis e di coca (Erythroxylum coca) sono state trovate in mummie del 1500 a. C. sono state scoperte in Perù. Ma soprattutto si dimentica che l’uso delle droghe leggere ottenute da moltissime piante è un fenomeno antico e quanto mai popolare che ha anche fatto dire che nel passato “Il regno vegetale offriva i suoi verdi deliri alla gente e a quei particolari esperti dei segreti della natura che si muovevano nel grande teatro farmaceutico” (Camporesi P. - Il pane selvaggio - Bologna, il Mulino 1983, p. 123).
Di questo fenomeno troviamo documentazioni nei grandi erbari stampati alla fine del Quattrocento e all'inizio del Cinquecento, che anche nel Seicento continuano a essere pubblicati e tradotti, e dove i vegetali sono descritti con le loro attività e con raffigurazioni spesso associate a figure umane per esplicitarne le virtù. Oltre agli erbari e con l’arrivo della stampa vi sono altre pubblicazioni, incluse ricette mediche per i poveri e almanacchi, che offrono a tutti l’accesso al mondo delle droghe indigene europee.
Fin dai tempi antichi gli Europei conoscono e usano piante capaci di produrre mutamenti fisiologici e hanno un nutrito inventario di narcotici vegetali, dall’oppio all’hashish ma anche il giusquiamo, lo stramonio (FOTO), la mandragora, la senna e il loglio. Gaspard Bauhin (1560 – 1624) nel suo erbario Pinax theatri botanici (1623) dedica una sezione speciale alle piante narcotiche e John Gerard (1545 – 1612) nell’Herball, or Generall Historie of Plantes (1597) raccomanda unguenti a base di succo di foglie di stramonio, con l'effetto di provocare allucinazioni. Louis Ferrant professore di medicina dell'Università di Bourges in un suo trattato sul tabacco da fiuto (1655) ricorda che serve a “riscaldare, asciugare, smuovere gli umori nel cervello e nei ventricoli ed espellerli” con effetti che oggi potremmo psicotici, mentre il popolo usa salvia, timo, lavanda, zenzero, piretro (crisantemo) e radici di iris. Documentazioni letterarie mostrano con chiarezza che sono i poveri, in campagna e in città, che fanno un uso delle erbe selvatiche come droghe anche come un’alternativa al cibo e per contrastare fame e sete, oltre a mantenere l'equilibrio umorale secondo le teorie mediche dell’epoca.
Erbe selvatiche sono individuate, raccolte e trattate soprattutto in un ambito di sapere tipicamente femminile e ancora poco studiato, anche se spesso citato o soltanto ipotizzato, forse perché gli studiosi europei hanno un atteggiamento di grande protezione e rispetto per il mondo vegetale che li circonda. Per questo nei pochi che si sono avventurati nella storia del consumo delle sostanze psicoattive in Europa prevale una sorta di ossessione per la stregoneria e, in generale, per le pratiche demonologiche e occulte. Non è certo se streghe e affini usassero preparati psicoattivi, ma quando storici e antropologi si sono avventurati nel campo delle conoscenze tradizionali riguardo all'uso delle erbe, inevitabilmente finiscono per limitarsi a esaminare tali attività (Goodman J. – Excitantia o come l’Europa dell’Illuminismo si diede al consumo delle droghe leggere – In Goodman J., Lovejoy P.E., Sherratt A. – Usi sacro, consumi profani. Il ruolo storico e culturale delle droghe – ECIG,1995).
Streghe, sciamani e azioni psichedeliche dei vegetali sembrano trovare recenti conferme nei funghi allucinogeni (Conocybe, Gymnopilus, Panaeolus, Pluteus, Psilocybe e Stropharia) contenenti l'allucinogeno serotoninergico psilocibina e il suo metabolita attivo psilocina. Queste molecole simili alla dietilamide dell'acido lisergico producono atassia, ipercinesia e allucinazioni, segni un tempo ritenuti tipici di comportamenti magici e di visioni interpretate come diabolici con i racconti di voli notturni riferiti dalle streghe. Inoltre il fungo Amanita muscaria ampiamente distribuito in tutta l'Europa contiene quattro allucinogeni: muscarina, muscimolo, muscazone e acido ibotenico dando origine a miti magici e anche alla leggenda secondo cui lo sciamano può bere l’urina delle renne che hanno mangiato il fungo sperimentando tutti i suoi effetti psicoattivi senza subire gli effetti tossici del fungo e così esercitando le sue cerimonie sciamaniche (Lee M. R., Dukan E-, Milne I. - Amanita muscaria (fly agaric): from a shamanistic hallucinogen to the search for acetylcholine - J R Coll Physicians Edinb., 48, 85 – 91, 2018. Quentin C., Michel L. - Amanita muscaria: Ecology, Chemistry, Myths - Encyclopedia, 1, 905 -914, 2021).