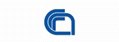I dazi e la fine dell’ordine globale
di Dario Casati
- 12 February 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
Le prime mosse del mandato presidenziale di Trump si sono manifestate con una pirotecnica manovra sui “dazi”, ci sia consentita la semplificazione, attraverso una serie di fulminei interventi differenziati per Paese partner e per settore, ubbidendo ad una strategia in apparenza casuale, ma mirata a colpire quella che gli Usa sembrano ritenere un’ingiusta concorrenza da parte degli altri partner. Il nome e l’insieme di misure che concorrono a formare i dazi hanno un ché di arcaico e risalgono ad un passato molto lontano. A riprova in Italia si può dire che non vi sia città o borgo storico che non presenti ancora caselli daziari, cinte daziarie, “pese” ormai inutilizzate e altri ricordi legati alla struttura urbanistica e alla memoria storica. Si riteneva che il processo di formazione dei moderni Stati unitari, la costruzione di entità sovranazionali come l’Ue, gli accordi mondiali come il Gatt e poi la Wto avrebbero cancellato o quanto meno ridotto e regolato l’impiego di un meccanismo fiscale legato agli scambi essenzialmente di natura protezionistica ormai superato.
Nell’accezione trumpiana, invece, risorge come strumento di politica economica per riequilibrare gli scambi e per stimolare la produzione interna gravando con un’imposizione alle frontiere i prodotti importati. La teoria economica e la stessa realtà del commercio internazionale provano l’esatto contrario. I dazi e il protezionismo impoveriscono un paese, frenano lo sviluppo economico e il progresso scientifico e tecnico che, al contrario, sono stimolati dalla concorrenza, limitano o annullano il vantaggio competitivo. A conferma delle conseguenze negative basti la constatazione della corsa negli Usa all’accaparramento dei metalli colpiti dai dazi annunciati lunedì 10 febbraio con il parallelo incremento dei prezzi per anticipare l’effetto dei dazi stessi.
Dobbiamo allora cercare di comprendere che cosa stia accadendo. I circa tre decenni della liberalizzazione degli scambi con la nascita della Wto e del connesso modello di accordo multilaterale sono quasi sfumati nei quattro anni terribili delle emergenze: a) sanitaria per la pandemia da COVID, b) inflazionistica nella fase di tentata ripresa economica mondiale, c) bellica iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e proseguita con il conflitto fra Hamas e Israele, d) economica con le difficoltà della ripresa mondiale. Il tutto in un contesto di crescita del debito pubblico totale e con l’incubo della transizione ambientale.
A quel punto si è compreso che vacillava l’ordine internazionale che si era creato negli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra. La sensazione di un possibile e spaventoso “liberi tutti” si è diffusa insieme ai primi annunci di Trump, ma allo stesso tempo si è allentata quando si è visto che in realtà i dazi imposti dagli Usa erano, almeno in parte “trattabili”, peraltro come le ritorsioni costituite da controdazi attuati dai Paesi bersaglio degli Usa. Le ritorsioni all’imposizione di misure unilaterali come i dazi di Trump sono legittimate anche in ambito Wto e dunque possibili.
Tuttavia questo modo di procedere improvvisando, con trattative dirette bilaterali e a partire da azioni unilaterali è negativo per la trasparenza dei mercati e per la libertà di scambio, oltre a danneggiare i Paesi con minore potere contrattuale come gran parte di quelli in via di sviluppo e con pesanti deficit negli scambi commerciali.
Il contesto di contrapposizioni anche su temi prettamente economici come gli scambi di beni e servizi in realtà va visto in un più generale clima mondiale di rottura degli equilibri del dopoguerra, testimoniato dall’ampiezza del ricorso a conflitti armati sempre più allargati. Questi in parte risentono di una serie di questioni aperte dalla fine della Seconda guerra e a lungo trascurate. Contrasti e da ferite che sono all’origine delle difficoltà di un mondo in cui l’ordine scaturito dalla Pace di allora si è dimostrato insufficiente per impedire nuove emergenze e per affrontarle in maniera coordinata. Dopo 80 anni le aree di conflitto sono ancora quelle dei tempi della guerra fredda, della cortina di ferro, delle ripetute crisi del Medio Oriente, innescate sulla base di contrasti plurisecolari e complicate dallo sviluppo economico e demografico. Tutto ciò non può essere imputato solo al dispotismo di alcuni dei protagonisti o alle bizzarrie di altri, né alla carenza di democrazia o alla presenza di democrazie deboli né, tanto meno al meccanismo dell’alternanza fisiologica destra/sinistra al momento del voto. 80 anni di pace, 30 di globalizzazione non sono stati sufficienti per eliminare i semi di discordie umane di ben più remota origine.
Attualmente si colgono i segni di tentativi di costruire nuovi meccanismi di equilibrio su scala mondiale, con lo sfaldamento, almeno apparente, delle aggregazioni e lo spostamento degli assi di interesse. Sembra da attribuire a questi fenomeni l’indebolimento di quello Occidentale Atlantico, il riformarsi al di là di quella che fu la linea della cortina di ferro di alleanze spostate più a Oriente e il panarabismo sorretto dall’estremismo islamico. È in questa luce che va considerato con grande attenzione il fenomeno del rigetto delle grandi Organizzazioni mondiali, a partire dall’Onu e a seguire con l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Wto, e, in Occidente, la stessa Nato, alla ricerca di un nuovo ruolo dopo l’apparente disimpegno parziale degli Usa. Ma anche grandi Progetti internazionali come la COP, la Conferenza dell’Ambiente mostrano un calante potere di attrazione di consenso.
Come in tutti i momenti di passaggio da una condizione ad un’altra ogni previsione appare azzardata perché dipendente da troppi e contrastanti fattori evolutivi. Come non è escluso il tramonto delle grandi Democrazie Occidentali, altrettanto imprevedibile è l’effettivo decollo di nuove aggregazioni di remota origine o il sorgere di nuove. O forse, come pensiamo, una rinnovata ripresa delle prime attorno a temi già noti, ma reinterpretati con rinnovato spirito di comunanza e di aggregazione con un nuovo salto in avanti.
Al Centro di un progetto di questo genere si colloca proprio la Questione agricola, di tutte la più antica, per il suo contributo alla costruzione del futuro dell’Umanità attraverso la fornitura di cibo in quantità e qualità sempre maggiori e potenzialmente migliori. L’agricoltura come produttrice di alimenti, soprattutto proteici, indispensabili ad uno sviluppo crescente della specie umana e insostituibili. Da ciò nasce, secondo logica, dopo le divisioni, un unico grande obiettivo unificante. Insieme alla spinta allo sviluppo della ricerca delle bioscienze mirate alla Salute umana, ad una migliore conoscenza del substrato biologico. Una rivoluzione che per funzionare ha bisogno del consolidamento della società umana attraverso nuove forme di aggregazione meno burocratiche ma più sostanziali di quelle esistenti. A partire ad esempio da quella europea, un sogno che ha guidato almeno due generazioni di europei e che oggi sembra arenato sulla burocratica cristallizzazione formale/burocratica che desta nella popolazione una crisi di rigetto dei popoli occidentali verso un modello di Società e di Sviluppo che sembra smarrito.
Antiche cause e recenti errori si combinano moltiplicando i fattori di crisi e la formazione di emergenze concatenate. Le prossime crisi non escludono guerre per il cibo se certi orientamenti antiproduttivistici saranno imposti riducendo così la produzione agricola e la sua disponibilità concreta. La stessa cosa avverrebbe anche se le indicazioni produttive e sanitarie fornite dallo sviluppo della ricerca scientifica venissero volutamente disattese o trasformate in vuoti rituali burocratici.
Tutto ciò considerato è chiaro che se non vogliamo trovarci di fronte a una possibile emergenza agricola impreparati come avvenuto per quella energetica, dobbiamo trovare il modo di conciliare e coordinare le politiche di transizione ambientale, energetica e, potenzialmente, agricola. A fronte di ciò la questione dei dazi, opposta alle logiche di apertura agli scambi commerciali, costituisce molto di più di una semplice guerra commerciale e per questo va affrontata con maggior ponderazione di quanto stia avvenendo ma per questo occorrono la volontà e l’umiltà di porre mano al disordine del mondo ed alla costruzione di un nuovo ordine su basi multilaterali condivise, magari proprio ripartendo dall’agricoltura.