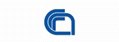Firenze più verde
Quali strategie nel Piano del Verde e degli Spazi Aperti della città di Firenze, recentemente approvato.
di Alberto Giuntoli
- 19 February 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
E’ stato approvato il Piano del Verde e degli Spazi Aperti della città di Firenze, è il risultato dell’intenso lavoro svolto dai tecnici della Direzione Ambiente con il supporto di esperti e scienziati dell’Università di Firenze e del CNR, un lavoro che ho coordinato insieme ad Ilaria Nasti direttrice della direzione Ambiente ed alla dirigente del servizio Parchi e Giardini, Cecilia Cantini.
Il piano ha declinato da un punto di vista tecnico la visione politica e sociale dell’amministrazione comunale, raccontata nella conferenza stampa del 31 Gennaio 2025 dalla Sindaca Funaro e dalla Vicesindaca Galgani, con un approccio che con azioni concrete sostenga la costruzione della città del futuro e l’aumento della resilienza dell’ecosistema urbano ai cambiamenti climatici. A partire da studi pregressi eseguiti, da gruppi ricerca del CNR, dal DAGRI, dal DIDA e dal DICEA dell’Università di Firenze (coordinati rispettivamente da Marco Morabito, Francesco Ferrini e Stefano Mancuso, Anna Lambertini e Gianni Bartoli) il Piano riporta le principali criticità della città in materia ambientale (ad es. gli hot spot climatici e le aree allagabili per eventi estremi), le sue peculiarità (ad. es. la struttura paesaggistica e storica del territorio) ma anche le opportunità e che offre per riequilibrare il rapporto tra Natura e costruito nel territorio urbano.
Firenze, come la grande maggioranza delle città europee può vantare una storia millenaria i cui successivi interventi hanno via via esteso l’area edificata anche sovrapponendosi tra loro, costruendo nel tempo un tessuto urbano denso di edificato e di abitanti. Anche per questo motivo, in alcune zone della città, ad es. nel centro storico e nei quartieri che si sono sviluppati rapidamente nel secondo dopoguerra, si riscontra una carenza di spazi verdi, pubblici ma anche privati. Come diretta conseguenza della eccessiva densità del costruito, nelle stesse zone si è rilevata anche una penuria di copertura arborea sia pubblica che privata. Il dato della copertura arborea è diventato un indicatore molto conosciuto a livello internazionale, spesso ricordato, insieme ad altri valori, nella “regola” per una città più sana e più resiliente, del 3-30-300: almeno 3 alberi visibili dalla finestra, almeno il 30% di copertura arborea e una distanza inferiore a 300 m per area verde pubblica fruibile (Konijnendijk, 2023). Anche quest’ultimo aspetto è stato oggetto dell’analisi del piano che ha elaborato le distanze di ciascun numero civico degli abitanti, all’accesso più vicino dei giardini pubblici fruibili, riuscendo così ad evidenziare quanti cittadini hanno spazi pubblici fruibili entro 300m, tra 330 e 550 m o oltre 500m e anche dove le abitazioni sono risultate meno servite. Questi aspetti hanno costituito le basi di riflessione per l’elaborazione di un piano che vuole restituire una città più vivibile perché più ombreggiata e fresca e con giardini raggiungibili in 15 minuti a piedi.
Ci siamo poi chiesti; “Quali sono gli spazi, attualmente disponibili, per introdurre o migliorare la naturalità del tessuto urbanizzato?” Nel Piano sono stati individuati gli spazi disponibili per la realizzazione di interventi “verdi” mediante l’incrocio dei dati del catasto strade e del censimento degli alberi pubblici, evidenziando aree libere da copertura arborea e/o inutilizzate (in primis, gli spazi marginali, anche quelli piccoli: gli slarghi inutili dei marciapiedi, il retro dei cassonetti, ecc..) dove appunto piantare altri alberi o realizzare nuove aiuole (tipo parklet, pocket park o addirittura rain garden). Serviranno anche questi piccoli spazi per ricostruire il tessuto connettivo vivo della città soprattutto attraverso l’implementazione di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions, NBS) quelle azioni cioè che privilegiano l’uso di sistemi biologici per aumentare la biodiversità e rendere l’ecosistema più resiliente rispetto ai cambiamenti climatici.
Un'altra delle strategie trasversali del piano prevede la realizzazione di interventi ad “alta densità di natura” spazi cioè dove ricreare habitat con presenza contemporanea di specie erbacee, arbustive ed arboree capaci di accogliere anche molte specie animali. Un approccio che abbiamo chiamato multi layer: strati di vegetazione che si sovrappongono tra loro e ottimizzano così i servizi ecosistemici offerti.
Tutti questi interventi convergono poi nel cercare di migliorare le criticità di alcune zone della città dove sono presenti gli hot spot, dove, almeno per una parte della popolazione, gli spazi verdi della città non sono raggiungibili entro 300 o 500 m, dove vi è una carenza di copertura arborea e quindi del suo effetto raffrescante, che aggrava l’isola di calore. Il Piano include tra le sue strategie più rilevanti il desealing ed il depaving cioè la sostituzione o la rimozione di pavimentazioni impermeabili per recuperare permeabilità del suolo mitigando in questo modo anche il rischio di allagamento in città.
Una parte del piano è poi dedicata alle altre componenti dell’ecosistema urbano quella sociale e quella tecnologica. In particolare sono previste azioni che riguardano la condivisione delle progettualità del Comune con la cittadinanza e la realizzazione di spazi con valenza sociale significativa come orti sociali, adventure playground, ecc.
Il Piano prevede l’utilizzo di molteplici strategie che affrontano la stessa criticità con modalità diverse, per favorire le azioni sinergiche tra loro ed amplificarne i servizi ecosistemici ed i benefici per la comunità cittadina. Le azioni mirano anche alla realizzazione di sistemi ridondanti, capaci di fronteggiare la stessa criticità con strategie parallele o anche sovrapposte: ad es. con la creazione di rain gardens e bioswale che servano ad alleviare la pressione sul sistema fognario durante eventi estremi.
Infine, mi preme sottolineare come nel Piano sia entrata la clausola, molto innovativa, che prevede che i risultati del Progetto Firenze, diventeranno immediatamente le best practices di riferimento del Piano. Un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Capellino in accordo e collaborazione con il Comune da me coordinato e portato avanti da un team di scienziati dell’Università di Firenze e del CNR sulla mitigazione dei CC ed il recupero della biodiversità in ambito urbano.
La rigenerazione urbana a Firenze non potrà più fare a meno di considerare come sostanziale l’apporto che la natura può offrire alla città e ai suoi abitanti.
Approfondimento: Konijnendijk, C. C. “Evidence-Based Guidelines for Greener, Healthier, More Resilient Neighbourhoods: Introducing the 3–30–300 Rule”. Journal of Forestry Research 34, fasc. 3 (1giugno 2023): 821–30. https://doi.org/10.1007/s11676-022-01523-z.
ScaricaIMMAGINE.jpg: Per la città sono necessarie molte strategie sinergiche e ridondanti