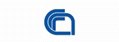“Dialoghi sul suolo e l’acqua”: La percezione dell’importanza del suolo in Italia
Dialogo con Carmelo Dazzi – Professore Ordinario, Università di Palermo
di Marcello Pagliai, Carmelo Dazzi
- 05 February 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
Pagliai – Carmelo, tu nel 2010 in occasione della giornata mondiale del suolo organizzasti un workshop a Palermo su “La Percezione del Suolo in Italia”. Ricordo che scopo del workshop, come da te dichiarato, era quello di ascoltare da “non addetti ai lavori” come il suolo era da essi percepito in modo da ricavare utili indicazioni per stimolare la diffusione della cultura del suolo in Italia. Ascoltare il modo in cui viene percepito il suolo da studiosi di altre discipline poteva certamente servire a meglio comprendere le ragioni sottese alla difficoltà che gli scienziati del suolo hanno sempre sperimentato nella diffusione della cultura del suolo in Italia.
Si è riusciti nell’intento? È cambiato qualcosa da allora?
Dazzi – Marcello caro, la tua domanda mi porta indietro nel tempo di 15 anni, e anche di più. Ricordo che l’idea di organizzare un workshop nel quale a parlare di suolo erano chiamati esperti di discipline anche molto diverse dalla scienza del suolo, nacque dalla consapevolezza che tutti i convegni che, a partire dal 1952 (anno di fondazione della SISS - Società Italiana della Scienza del Suolo), sono stati organizzati fino ad oggi, hanno visto “scienziati del suolo” che parlavano di suolo ad altri “scienziati del suolo”. Così era accaduto anche nel convegno nazionale organizzato sempre a Palermo nel 1997, sul tema “Per una Cultura del Suolo in Italia”. E così, purtroppo continua ad accadere.
Noi sappiamo che il suolo è una risorsa fondamentale per la vita sulla terra, che svolge numerose funzioni e fornisce servizi essenziali per le attività umane e per la sopravvivenza degli ecosistemi. Siamo inoltre consapevoli che oggi il suolo è sottoposto a pressioni ambientali ed antropiche sempre più forti che danneggiano per sempre la capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. È quindi imperativo intervenire per proteggere il suolo al fine di garantire la sua funzionalità alle generazioni future. Il non perseguimento di questo obiettivo mina fortemente la sostenibilità ambientale ed economica della nostra società, ancor di più nel nostro fragile, complesso e tanto maltrattato paesaggio italiano. Nonostante l’importanza di queste tematiche e l’urgenza di una strategia di interventi (politici, economici, sociali) per la difesa del suolo, si registra una scarsa percezione da parte della società civile. È in un contesto così problematico che si è inserito il workshop cui tu facevi riferimento che, tramite un focus sulla percezione del suolo mira ad affrontare il nodo cruciale culturale della diffusione della Scienza del Suolo e della Pedologia in Italia. Ma la vera innovazione è stata quella di farlo a ruoli invertiti invitando economisti, bancari, architetti, dirigenti d’azienda, giornalisti, forze dell’ordine, insegnanti di scuola, colleghi di altri settori a parlarci della loro percezione sul suolo.
Un assioma molto noto fra gli scienziati del suolo dice che “la qualità della vita dell'uomo dipende dalla qualità dei suoli”. In effetti, se facciamo mente locale a quella che è stata l'evoluzione delle grandi civiltà che si sono evolute nel tempo ci accorgiamo che queste si sono evolute laddove vi era la presenza di suoli fertili accompagnata anche alla presenza di acque di buona qualità.
Tu mi chiedi se è cambiato qualcosa.
E da rilevare che nell'ultimo decennio a livello nazionale (ma anche internazionale) sono state avviate numerose iniziative volte sia alla diffusione della cultura del suolo che della consapevolezza della sua importanza nel mantenimento degli equilibri ambientali e per la stessa qualità della vita dell'uomo ma, non siamo ancora di fronte ad una diffusione capillare nell'ambito delle tematiche ambientali legate al suolo sia nella società civile che soprattutto fra amministratori e politici
Pagliai – Continuando a ricordare il tuo impegno, del resto comune a tanti altri ricercatori nel campo della scienza del suolo, tu, sul finire del secolo scorso, hai documentato come, in una delle pianure nella tua Sicilia, dagli ’60 (gli anni dell’inizio del boom economico) al 1996 si è perso, a causa del consumo di suolo (cementificazione), oltre l’80% dei suoli agricoli appartenenti alla migliore classe di fertilità. Ancora oggi il consumo di suolo aumenta vertiginosamente al ritmo di oltre 2 metri quadrati al secondo! Uno degli slogan dei pedologi alla fine del secolo scorso era “La gestione del suolo e delle risorse idriche sarà la sfida del futuro”: sfida che, a mio avviso, abbiamo perso. Si parla ancora di eventi eccezionali quando accadono le catastrofiche alluvioni o i lunghi periodi di siccità e sembra che i cambiamenti climatici siano esplosi all’improvviso, quando ormai sono anni che si manifestano.
Se è vero che la gestione del territorio è una questione politica, è anche vero che la ricerca ha il compito di indicare quali scenari si prospetteranno a seconda delle opzioni intraprese. Per quanto riguarda la gestione e conservazione del suolo la ricerca ha sempre indicato e previsto quello che poi è accaduto. Abbiamo sempre ribadito che una non corretta gestione del suolo avrebbe portato poi, nel lungo termine, alla sua degradazione. Tu che nella tua lunga carriera ti sei sempre dedicato, oltre alla diffusione dei risultati delle tue ricerche secondo quanto previsto dagli indici bibliometrici, anche alla ricerca di un colloquio e di un’interazione con i decisori politico-amministrativi, cosa dobbiamo fare per attirare una maggiore attenzione sui risultati e sulle indicazioni della ricerca pedologica?
Dazzi – Sono fortemente convinto che noi scienziati del suolo dovremmo usare strategie di comunicazione per le quali abbiamo poca dimestichezza. Gli scienziati sono in genere inesperti e improduttivi nel comunicare al grande pubblico e quindi anche ai politici.
Indagini svolte nel campo delle scienze cognitive, evidenziano che gli individui sono "ragionatori motivati", cioè persone che filtrano le informazioni e focalizzano l’interesse solo su quelle compatibili con il proprio sistema di valori. Di conseguenza, svolgere attività scientifiche di rilevanza politica in un'era caratterizzata da problemi urgenti e impegnativi legati soprattutto al sistema economico, senza stimolare efficacemente i responsabili delle politiche, può rivelarsi insoddisfacente e improduttivo.
Ecco allora che, per affrontare le sfide ambientali globali, dobbiamo “etichettare” il suolo in modo tale da evidenziarne gli aspetti economici, sociali e politici. Tale etichetta deve essere chiara e diretta per spingere la società civile a considerare il suolo in un’ottica adeguata ai tempi. Richiamare l'attenzione del grande pubblico e dei politici, etichettando il suolo come una risorsa "economica" che influenza profondamente i sistemi "sociali" e "politici", potrebbe essere la strategia vincente per il raggiungimento di una efficace gestione del suolo.
Pagliai – Quale futuro attende le nuove generazioni?
Dazzi – A partire dagli anni 1980 è cresciuta la consapevolezza che suoli sani e di buona qualità, che filtrano l'acqua, immagazzinano il carbonio e forniscono un habitat per innumerevoli specie, sono la base della nostra esistenza. Di pari passo sono cresciute le iniziative e gli enti, pubblici e privati, che si occupano di tutela e conservazione del suolo e che si affiancano alle società scientifiche che operano nel nostro Paese nel campo della scienza del suolo.
Notevole impulso alla diffusione della consapevolezza della importanza del suolo negli equilibri ambientali è stato dato dalla istituzione a livello globale della “Giornata Mondiale del Suolo” che si celebra il 5 dicembre di ogni anno. Nel nostro Paese sin dal 2003 le sedi ove si svolgono manifestazioni celebrative per il suolo aumentano anno dopo anno con il coinvolgimento di diverse centinaia di studenti della scuola secondaria. Se a ciò si aggiunge che da qualche anno, nei testi scientifici delle scuole secondarie sono stati introdotti capitoli che trattano del suolo e dei servizi ecosistemici che offre, possiamo dirci ottimisti circa la diffusione della cultura del suolo fra le nuove generazioni. La strada sarà lenta ma è certamente tracciata.