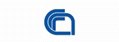In primo piano
Dialoghi sul Verde: “La legge sul ripristino della natura, limiti e benefici”
Dialogo con Roberto Danovaro, Professore Ordinario di Ecologia e sostenibilità ambientale presso l’Università Politecnica delle Marche.
Nicoletta Ferrucci e Roberto Danovaro 28 January 2026

Ferrucci: Dalla fine del secolo scorso ad oggi si registra in tema di biodiversità un crescente attenzione della politica ambientale di matrice internazionale e, a cascata, unionale e nazionale, che ruota attorno ad una concezione antropocentrica del rapporto tra l’uomo e la natura: da un lato la maturata consapevolezza, sulle orme della scienza, del ruolo strategico che la biodiversità riveste per la nostra vita, attraverso un caleidoscopio di benefits che è in grado di fornirci; dall’altro la presa d’atto sempre più drammatica delle conseguenze perverse sull’ambiente e sulla vita umana legate alla costante, vertiginosa erosione e perdita delle sue componenti, potenziata dalle reciproche profonde interconnessioni con il climate change. Ma gli obiettivi sottesi alla gamma di strumenti ciclicamente forgiati per arginare la crisi della biodiversità sono stati reiteratamente disattesi dai risultati deludenti della relativa implementazione. Ad oggi scorrono davanti agli occhi di chi legge la letteratura scientifica e i Report che accompagnano i monitoraggi, dati che continuano a riportare percentuali inquietanti di specie vegetali e animali in via di estinzione a livello globale; trasformazioni radicali di interi ecosistemi, costante perdita a ritmi incalzanti di habitat. Nel tuo prezioso volume dal titolo "Restaurare la Natura", hai magistralmente disegnato questo scenario: potresti qui tracciarne le linee fondamentali, e individuare quali sono stati, a tuo parere, i limiti della politica ambientale antecedente alla Nature Restoration Law?
Danovaro: Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento marcato dell’attenzione verso le tematiche ambientali e, in particolare, verso la crisi globale della biodiversità. Le basi concettuali di questa consapevolezza sono state definite in modo esplicito a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, ma non derivano tanto da una visione puramente ecocentrica o antropocentrica del rapporto tra uomo e natura. Sono piuttosto il risultato di un progressivo accumulo di evidenze scientifiche che hanno documentato una profonda alterazione di habitat ed ecosistemi, accompagnata da una perdita significativa di biodiversità a scala globale. In questo contesto, l’istituzione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e, successivamente, dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), ha svolto un ruolo cruciale nel chiarire, da un lato, il contributo del cambiamento climatico nell’amplificare gli impatti diretti delle attività umane e, dall’altro, nel rendere evidente come la perdita di biodiversità non rappresenti soltanto una perdita di valore estetico, culturale o simbolico del rapporto con la natura; incide direttamente sulla capacità degli ecosistemi di fornire beni e servizi ecosistemici indispensabili al benessere umano, quali la produzione di ossigeno, la disponibilità di acqua pulita, la sicurezza alimentare e la regolazione dei processi biogeochimici. Tali servizi hanno inoltre una rilevanza economica sostanziale, poiché ecosistemi integri e funzionali risultano più produttivi, resilienti e capaci di generare valore nel lungo periodo rispetto a sistemi degradati. È ormai ampiamente dimostrato che la perdita di biodiversità comporta costi economici elevati e compromette la sostenibilità delle attività umane. La Nature Restoration Law nasce proprio dalla consapevolezza che, anche qualora la comunità internazionale riuscisse a raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi globali più recenti, come il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, ovvero la protezione del 30% degli ambienti terrestri e marini entro il 2030, ciò non sarebbe comunque sufficiente a compensare il livello di degrado che interessa oggi una parte consistente degli ecosistemi utilizzati dall’uomo. Molti ecosistemi terrestri e marini risultano infatti già erosi o danneggiati fino a circa il 75% della loro estensione originaria. La sfida attuale, pertanto, non consiste esclusivamente nel proteggere ciò che è ancora relativamente integro, ma anche nel promuovere azioni concrete di restauro ecologico, volte a recuperare le funzionalità perse e a mitigare i danni prodotti dall’Uomo negli ultimi decenni.
Il ruolo centrale del clima nella proliferazione delle specie aliene
Marco Bindi 28 January 2026

Il cambiamento climatico non è soltanto uno sfondo ambientale, ma il fattore trainante primario che sta trasformando radicalmente i sistemi agricoli e favorisce l'ingresso di specie aliene.
L’area del Mediterraneo può essere identificata come un vero e proprio "hotspot" di vulnerabilità che reagisce alle sollecitazioni atmosferiche con una rapidità e un'intensità decisamente superiori rispetto alla media globale. I dati osservati dipingono un quadro inequivocabile caratterizzato da un innalzamento termico costante, con temperature che nell'area mediterranea crescono più velocemente della media mondiale segnando un +1,5°C rispetto all'era pre-industriale, mentre parallelamente i regimi pluviometrici risultano profondamente alterati con una diminuzione delle precipitazioni annuali stimata tra il 10% e il 20% negli ultimi quarant'anni e un concomitante aumento degli eventi estremi, come siccità prolungate e ondate di calore che hanno visto incrementare la loro frequenza del 50% e la loro durata di diverse settimane. Questi driver climatici esercitano un impatto diretto e immediato sulla fisiologia delle colture agrarie, influenzando pesantemente sia la quantità che la qualità dei raccolti attraverso meccanismi come l'accelerazione dei cicli vitali dovuta al calore eccessivo, che porta a maturazioni anticipate a scapito della qualità, e il cosiddetto "caos fenologico", ovvero uno sfasamento delle fasi di crescita come fioriture precoci che espongono le piante a gelate tardive e disallineano i tempi con gli insetti impollinatori, fino ad arrivare a blocchi fisiologici totali quando, per difendersi dalla carenza idrica, le piante chiudono gli stomi arrestando di fatto la fotosintesi e la crescita.
Notiziario
Prossimi eventi
"Bosco, Albero, Uomo" - Mostra fotografica
Il valore del bosco: stretegie per le filiere del legno in Italia
Genomica e biotecnologie di nuova generazione in olivo
La zootecnia nelle aree alpine: innovazioni disponibili per migliorare la sostenibilità dei sistemi produttivi
Riflessioni sul convegno organizzato dalla Sezione Nord-Est dell’Accademia dei Georgofili a Bolzano il 5 dicembre 2025.
Bruno Ronchi 28 January 2026

Le piante e i composti organici volatili (VOC)
Ecco come le comunicano le piante tra loro.
Giuliano Mosca 28 January 2026

Dopo aver partecipato con vivo interesse alla conferenza del Prof. Francesco Loreto (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) svoltasi presso l’Accademia dei XL a fine 2025, si riporta di seguito una sintesi circa le attuali conoscenze sui VOC (Composti Organici Volatili) prodotti ed emessi dalla chioma e dalle radici delle piante.
Fritz Went (Nature, 1960), botanico olandese, noto per i suoi studi sugli ormoni vegetali e sulla chimica dell’atmosfera, propose che la tipica foschia blu che compare sopra i boschi sia causata dai composti organici volatili (soprattutto terpeni e isoprene) emessi dagli alberi. I terpeni sono una vastissima classe di composti organici prodotti dalle piante, soprattutto dagli alberi e in particolare dalle conifere. Sono formati da unità ripetute di isoprene (C₅H₈) e sono i principali componenti di resine e oli essenziali che conferiscono gli aromi caratteristici di molte specie come pino, eucalipto, agrumi e altri.