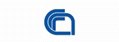Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
Il ruolo della fotosintesi e della nutrizione minerale
di Silverio Pachioli
- 23 April 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
Per assicurarsi il successo riproduttivo, in biologia fitness, le piante utilizzano tre processi fondamentali: a) la crescita, che consiste nella conversione dei metaboliti primari in elementi strutturali (foglie, radici, fusto, ecc.); b) la fertilità, che si estrinseca nella produzione di semi numerosi e vitali; c) la difesa, ossia la capacità di resistere all’attacco di patogeni.
Ciascuno di questi processi richiede lo stesso pool di risorse (carbonio fotosintetico, acqua, elementi minerali), con il risultato di essere interdipendenti, complementari e concorrenti. La forte evoluzione dell’agricoltura moderna, basata essenzialmente sulla selezione di cultivar altamente produttive, ha avuto come conseguenza una riduzione/perdita dei caratteri di resistenza, “occultata” spesso da un forte incremento dell’uso di prodotti fitosanitari. Lo studio dei rapporti crescita/difesa è complesso e coinvolge diversi aspetti dell’evoluzione e dello sviluppo delle piante.
Secondo Züst e Agrawal (2017), il costo della difesa, come conseguenza diretta crescita/difesa, si può definire come:
1) Costo genetico, legato al processo di selezione delle nuove cultivar e che promuove la crescita e la resa a svantaggio delle capacità di difesa. Si verifica a livello di popolazione.
2) Costo di allocazione, corrisponde alla riduzione della crescita a seguito dell’induzione dei meccanismi di difesa. Si verifica su scala di individuo.
3) Costo metabolico, corrisponde all’energia e alla quantità di elementi utilizzati in una via metabolica particolare. Si verifica su scala di metabolismo.
4) Costo ecologico, corrisponde alle conseguenze dell’acquisizione di resistenza ad uno specifico patogeno su altri aggressori o su ausiliari utili. Si verifica in una rete trofica.
Numerose ricerche hanno cercato di analizzare i “costi fisiologici” della resistenza indotta sull’equilibrio fra crescita e difesa. La teoria principale suggerisce che l’energia e le risorse che vengono dirottate verso la sintesi di composti difensivi non possono essere utilizzate nel metabolismo primario, provocando così riduzione della crescita e altri costi di fitness (Heill M., 2002). Inoltre, alcune delle molecole (come SA e le specie reattive dell’ossigeno coinvolte nel “burst ossidativo”) implicate nelle vie di segnalazione che si verificano all’inizio della risposta induttiva, possono avere effetti autotossici (Rasmussen et al., 1991).
I “costi fisiologici” possono essere molto marcati in caso di carenze nutritive o in condizioni sfavorevoli di coltivazione. Anche se ulteriori studi devono essere intrapresi per comprendere meglio il fenomeno, sembrerebbe che le difese indotte possano essere benefiche per le piante in presenza di “bioaggressori”, risultando un “costo” per lo sviluppo delle piante in assenza di patogeni.
In definitiva, volendo utilizzare al meglio questi prodotti è necessario considerare una serie di fattori:
• Specie, cultivar, stadio fisiologico, relazione cultivar-genotipo
• Costo fisiologico
• Modalità di applicazione, dosaggi, eventuali fitotossicità, tempi di induzione
• Condizioni ambientali (temperatura, umidità, luce)
• Fertilizzazione (macro e microelementi)
Gli induttori di resistenza non hanno, in generale, un’azione biocida diretta, ma agiscono unicamente sulle risposte di difesa delle piante. Nei casi di forte pressione delle malattie o in condizioni non ottimali di nutrizione idrico-minerale (carenze/eccessi di elementi nutritivi) e fotosintesi (luminosità, temperatura, igrometria, CO2) l’efficacia di queste sostanze può notevolmente diminuire. L’induzione di resistenza può richiedere un intervallo di tempo tra il momento dell’intervento e quello dell’effettiva efficacia del trattamento (induzione). In condizioni controllate risulta abbastanza semplice programmare l’introduzione del patogeno/insetto. In campo, l’integrazione di questi prodotti nei programmo di gestione della difesa delle piante richiede una perfetta conoscenza del patogeno, degli insetti nocivi, dei tempi e delle modalità di attivazione delle resistenze endogene.
La piramide della “salute” delle piante di Kempf
John Kempf è stato uno dei pionieri dell’agricoltura rigenerativa ed è il fondatore di AEA (Advancing Eco Agriculture). Kempf sostiene che “le piante sane possono diventare completamente resistenti alle malattie e agli insetti”. Il sistema della piramide messo a punto da Kempf mette in evidenza l’importanza primaria della fotosintesi su tutti i successivi processi metabolici: sintesi proteica, sintesi di lipidi e di molecole secondarie”. Solo con un efficiente processo fotosintetico le piante possono “rispondere” attivamente all’attacco di “bioaggressori” e a stress di natura abiotica. L’analisi particolareggiata dei diversi stadi della piramide può aiutare a comprendere le basi fondamentali dell’intero sistema di difesa delle piante e i possibili interventi esterni mediante induttori di resistenza.
Fig. Piramide della salute delle piante di Kempf