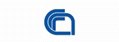Limiti normativi alla valorizzazione degli scarti per l’agricoltura
di Petronia Carillo, Biagio Morrone, Stefania De Pascale
- 16 April 2025
Ultimi inserimenti
- Dalla cucina paleolitica alla postcucina
- Limiti normativi alla valorizzazione degli scarti per l’agricoltura
- Sei mesi per cambiare il mondo?
- Eunice Newton Foote (1819-1888): la scienziata che aveva previsto il cambiamento climatico, ma non fu creduta, in quanto donna
- Dialoghi sulle biotecnologie: “Il contributo delle TEA per il Miglioramento genetico della canapa”
L’agricoltura sta vivendo una grande trasformazione, chiamata a produrre cibo in modo sostenibile, rispettando l’ambiente. In questo scenario, il riutilizzo degli scarti agroindustriali può rappresentare una soluzione concreta per migliorare la salute del suolo, ridurre l’inquinamento e utilizzare meglio le risorse naturali. Nonostante i numerosi vantaggi ambientali ed economici, l’applicazione pratica di queste soluzioni su larga scala resta limitata da ostacoli normativi e burocratici.
Una delle strategie più promettenti consiste nel trasformare i residui agricoli in compost, fertilizzanti organici, biostimolanti o bioenergie. Questi prodotti, se ben utilizzati, possono aumentare la fertilità naturale del suolo, migliorarne la struttura, favorire la biodiversità microbica e aumentare la capacità di trattenere acqua e nutrienti. Inoltre, contribuiscono a sequestrare carbonio nel terreno, riducono l’erosione e permettono agli agricoltori di diminuire l’uso di fertilizzanti chimici, con evidenti vantaggi ambientali ed economici.
Studi scientifici dimostrano che applicare compost regolarmente aumenta il contenuto di sostanza organica stabile nel terreno e migliora l’attività biologica, favorendo la disponibilità naturale di nutrienti. Anche il digestato, cioè il materiale derivato dalla digestione anaerobica (processo di degradazione biologica in assenza di ossigeno) di residui agricoli o zootecnici, rappresenta una valida alternativa ai fertilizzanti minerali classici grazie al suo elevato contenuto di azoto, fosforo e potassio. Nonostante queste potenzialità, l’uso di residui agricoli incontra forti barriere legislative. Uno dei principali problemi riguarda la definizione giuridica dei materiali: distinguere chiaramente tra “rifiuto”, “sottoprodotto” e “prodotto finito” non è ancora semplice.
A livello europeo, la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) ha introdotto il concetto di “fine del rifiuto” (end-of-waste), ma mancano ancora linee guida precise per molte categorie di biomasse agricole. Di conseguenza, ogni Paese della UE si regola in autonomia, creando confusione e incertezza per gli operatori. In Italia, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) ha definito la figura del “sottoprodotto”, stabilendo quando un materiale può essere riutilizzato senza essere considerato rifiuto. Tuttavia, nella pratica, la decisione finale dipende spesso da valutazioni discrezionali delle autorità regionali o locali, come le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA). Questo genera incertezza per le aziende agricole e limita gli investimenti in sistemi di compostaggio o digestione anaerobica. Le autorizzazioni ambientali per impianti di trattamento biologico richiedono procedure lunghe e costose, spesso proibitive per piccole e medie realtà agricole. Il recente Regolamento europeo 2019/1009 sui fertilizzanti ha iniziato a chiarire alcuni aspetti, introducendo standard comuni per i fertilizzanti derivati da materiali riciclati. Tuttavia, molti residui agricoli restano ancora esclusi o soggetti a requisiti tecnici troppo severi, che ne limitano la competitività sul mercato. La bioeconomia e l’economia circolare sono oggi pilastri della transizione verde europea, citati esplicitamente nel Green Deal e nella strategia Farm to Fork.
Tuttavia, per molto tempo la normativa ha trascurato le specificità delle filiere agricole, regolando spesso il trattamento dei residui come se fosse un’attività industriale, anche quando svolta direttamente in azienda. Per superare queste difficoltà è necessario agire su più fronti. A livello normativo, occorre armonizzare definizioni e criteri tecnici, semplificare il riconoscimento della “fine del rifiuto” e includere chiaramente la valorizzazione dei residui tra le pratiche premiate dalla Politica Agricola Comune (PAC). Dal punto di vista operativo, è importante sviluppare sistemi di certificazione per compost e digestati, promuovere strumenti digitali per tracciare i flussi di biomasse e incentivare investimenti in impianti locali di recupero e valorizzazione. In questa transizione, gli agronomi rivestono un ruolo centrale. Grazie alle loro competenze multidisciplinari, possono supportare gli agricoltori nella scelta e nell’applicazione delle migliori soluzioni.
Tuttavia, per realizzare pienamente un’agricoltura circolare è necessario il contributo integrato di diverse figure professionali (economisti, ingegneri ambientali, biotecnologi) e istituzioni capaci di collaborare per trasformare gli scarti agricoli da problema a risorsa. La valorizzazione degli scarti agroindustriali rappresenta, quindi, un’opportunità concreta per rendere l’agricoltura europea più sostenibile, resiliente e competitiva. Ma affinché queste potenzialità diventino realtà, fondamentale è il ruolo dei decisori politici per superare rapidamente gli ostacoli normativi e burocratici che ancora ne limitano l’applicazione diffusa.
Approfondimento: Riferimenti normativi.pdf