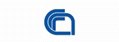Sei mesi per cambiare il mondo?
di Dario Casati
- 16 April 2025
Ultimi inserimenti
- Dalla cucina paleolitica alla postcucina
- Limiti normativi alla valorizzazione degli scarti per l’agricoltura
- Sei mesi per cambiare il mondo?
- Eunice Newton Foote (1819-1888): la scienziata che aveva previsto il cambiamento climatico, ma non fu creduta, in quanto donna
- Dialoghi sulle biotecnologie: “Il contributo delle TEA per il Miglioramento genetico della canapa”
Stanno per concludersi i primi 100 giorni della Presidenza di Trump. Un’antica e nota regola della politica vuole che essi siano dedicati alla presentazione delle linee guida e dei relativi primi provvedimenti di un Governo appena insediato. In tutto ciò vi è un fondo di logica verità e di pragmatismo. Il rapporto del vincitore con l’elettorato è vivo, le promesse elettorali sono recenti e i tempi per realizzarle abbondanti. Tutte le premesse indicano che anche Trump si voglia attenere a questa regola non scritta, per quanto in modo molto personale e con frenetici cambiamenti di comportamento. I tempi, per ogni Presidente Usa, sono brevi, la scadenza elettorale biennale del rinnovo di metà delle Camere è molto prossima e costituisce una prima verifica spesso impietosa. Ora, dopo il caos suscitato a livello mondiale e negli stessi Usa, The Donald compie la “mossa del cavallo” con la concessione di una tregua di 90 giorni prima dell’attivazione dei dazi, con l’esclusione di quelli elevati ulteriormente verso la Cina, ma con qualche sapiente eccezione. In sintesi, la partita rimane aperta e i cento giorni diventano 6 mesi, giusto il tempo per trattare con le controparti involontarie del suo gioco.
Le questioni aperte nei 100 giorni
Il contesto mondiale letteralmente sconvolto da Trump riguarda almeno tre questioni chiave, due evidenti e specifiche e una terza di ordine generale.
La prima è la questione delle guerre in corso, almeno di quelle maggiori come il conflitto russo/ucraino e quello fra (alcuni) paesi arabi e Israele. Entrambi hanno origini remote e sono stati acuiti dalle conseguenze della Seconda guerra a seguito delle decisioni dei cinque Paesi vincitori. The Donald interviene pesantemente, con imposizioni non sappiamo quanto gradite dai diretti interessati, in una logica che sembra, ma non è, coerente col disegno della pace e degli equilibri di allora. L’atteggiamento verso i Paesi europei lascia senza fiato, perché dopo 80 anni gli Usa sembrano volersi ritirare dal continente, in particolare dai Paesi occidentali, inclusi i cofirmatari dell’accordo di Jalta come Francia e Gran Bretagna. Il contrasto è forte con la visione lungimirante degli Usa di Roosvelt che con il Piano Marshall riattivò concretamente le economie dei Paesi stessi, vinti e vincitori. Una rottura a dir poco epocale ma, soprattutto, estremamente pericolosa nell’attuale fase di tensioni di natura geopolitica. Straordinaria lungimiranza all’epoca, penosa e incomprensibile miopia ora.
La seconda questione è rappresentata dalla cosiddetta “guerra dei dazi” e cioè dalla decisione Usa di imporre dazi più elevati di quelli già in vigore alle importazioni in provenienza dalla quasi totalità dei Paesi del mondo in maniera unilaterale e senza una preliminare eventuale trattativa. In particolare sarebbero colpiti i maggiori esportatori verso gli Usa e cioè Canada, Messico, Cina, Paesi dell’Ue, Gran Bretagna. L’imposizione di dazi, peraltro, è regolata da norme approvate nell’ambito della Wto ed è soggetta, se applicata al di fuori di queste, al diritto del Paese leso di ricorrere a ritorsioni proporzionate al danno subito. Ciò apre la strada a complesse negoziazioni che richiedono, di norma, periodi molto lunghi per la conclusione. I dazi si sono confermati nel tempo un’arma spuntata e controproducente, utilizzata nel quadro di politiche protezionistiche. Al contrario, la liberalizzazione degli scambi, in particolare se attuata in base a regole chiare e condivise, accresce la ricchezza prodotta dalle parti, favorisce l’aumento degli scambi e ottimizza la distribuzione della produzione fra i diversi Paesi sulla base dei rispettivi vantaggi competitivi.
La terza questione costituisce il vero nocciolo dell’intero problema e riguarda il ruolo egemonico degli Usa a partire dal Novecento, il suo apparente declino e l’embrionale tentativo di formazione di nuove aree di influenza man mano che l’egemonia degli Usa diviene meno esclusiva. L’asse della Storia che nei millenni ha oscillato spostandosi da Est a Ovest è forse in movimento, mentre il blocco Occidentale imperniato sugli Usa perde vigore. È difficile trovare una risposta a queste ipotesi, ma la crisi anche interna degli Usa pone seri interrogativi sul futuro. Certamente il tentativo implicito nella globalizzazione attuata negli ultimi decenni sembra aver lasciato dietro a sé i segni di un possibile cambiamento, mentre le mosse attuali di Trump mostrano una inattesa ricerca del Paese guida di recuperare il ruolo sin qui ricoperto nella coalizione Occidentale “lato sensu”.
Il ruolo dell’Italia nel quadro mondiale
L’Italia, con l’esito del Secondo Conflitto è entrata a far parte della coalizione ed anzi ha assunto nel tempo un ruolo chiaro di appartenenza e di sostegno dell’Occidente sia come membro della Nato, sia con la sua condizione di Paese fondatore dell’Ue in tutto il percorso di quest’ultima. È stata una scelta obbligata inizialmente, favorita dall’apertura Usa con il Piano Marshall e conforme alle conclusioni dell’accordo di Jalta. Oggi è data per scontata dalla quasi totalità delle forze politiche, anche da quelle contrarie agli inizi (si ricordi ad esempio la dura contesa sull’adesione alla Nato da parte della sinistra) e ora con la questione ucraina sofferta da una parte dello schieramento politico.
L’Italia per storia, cultura, democrazia rappresentativa e posizione geografica è parte di questa coalizione e anche nel momento attuale mostra di volere confermare la sua.
Il problema del settore agricolo nell’attuale crisi
Le grandi crisi in atto hanno inaspettatamente mostrato l’importanza del settore Agroalimentare in tutto il mondo, anche in Europa e in Italia. Basti considerare il peso che nella guerra russo/ucraina ha avuto sia come obiettivo strategico nel campo di battaglia sia come effetti sul mercato mondiale delle materie prime agricole. Ricordiamo che lo sblocco delle merci agricole nell’area del Mar Nero è stata fra i primi punti ad essere affrontata proprio in relazione alla navigazione ed all’import/export dei prodotti agricoli di quell’area.
La questione dei dazi da noi è stata vista molto nell’ottica del nostro commercio estero agroalimentare. L’Informazione ha insistito molto su questo tema lasciando in secondo piano il fatto che l’Italia è oggi il quarto paese esportatore di prodotti manufatti anche industriali oltre che agricoli e che l’attivo della bilancia agroalimentare vede in passivo crescente lo storico deficit della componente agricola e in crescita l’attivo di quella alimentare. Siamo Paese manifatturiero anche in questo comparto e mentre esaltiamo i prodotti finiti sembriamo avere perso di vista il fatto che la produzione agricola è da decenni in calo complessivo e che una parte significativa delle esportazioni tipiche, formaggi e carni lavorate, pasta, olio d’oliva è resa possibile grazie a crescenti importazioni di prodotti agricoli di base. Questo calo deriva in gran parte dalla riduzione della produttività agricola e da una serie di vincoli imposti al settore. Il problema è noto ed è stato più volte richiamato dal settore stesso, ma non sembra fare breccia nell’opinione pubblica ormai nettamente più urbana che rurale.
Il futuro dell’alimentazione e dell’economia agricola
Quale che sia il futuro della guerra dei dazi, del trumpismo di questi giorni e degli assetti geopolitici del mondo, quello agroalimentare rimane strettamente collegato al costo ed alla disponibilità di materia prima agricola da trasformare in alimenti. I problemi mondiali sul tappeto debbono ricordarci che l’Italia, come ogni altro Paese, ha comunque bisogno di disporre di materie prime agricole in quantità tecnicamente producibili e con i requisiti di sostenibilità che possiamo applicare, ma che il vero problema, come per l’intera economia nazionale, è la produttività, sia agricola che industriale, entrambe in calo relativo e assoluto nei confronti con il resto del mondo. La ripresa economica appena accennata e stroncata inopportunamente sarà sostenuta ed alimentata dalla ripresa della produttività e dalla liberalizzazione degli scambi.