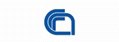Foreste e gestione forestale: il ruolo dell'Unione Europea sotto i riflettori
di Piermaria Corona
- 02 April 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
Negli ultimi tempi, il dibattito sull’Unione Europea (UE) si è intensificato, mettendo in luce questioni cruciali sul suo ruolo e sulle sue politiche. Indirettamente, anche quello forestale emerge come ambito di riflessione.
Il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea e di cui si è celebrato in questi giorni l’anniversario, non contemplava esplicitamente le foreste tra le aree di competenza comunitaria. La gestione forestale era ritenuta una prerogativa nazionale, con ciascuno Stato membro responsabile della definizione e dell'attuazione delle proprie politiche e normative in materia. Nel corso del tempo, tuttavia, l'UE ha progressivamente ampliato il proprio intervento anche nel settore forestale, sebbene in maniera indiretta, attraverso normative ambientali, strumenti di finanziamento per lo sviluppo rurale e iniziative di cooperazione tra gli Stati membri. L'UE non dispone, però, ancora di una politica forestale comune, sebbene nel 2021 sia stata adottata la Strategia Forestale Europea per il 2030.
In Europa, la superficie forestale ha registrato un incremento costante a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso, con un aumento che nell'ultimo trentennio è stato di circa lo 0,3% all’anno. Questa crescita è il risultato di una combinazione di fattori costituiti da rimboschimenti, piantagioni destinate alla produzione di legno e, in misura prevalente, espansione naturale delle foreste favorita dall'abbandono di terre agricole; nelle regioni settentrionali e al limite della vegetazione arborea anche i cambiamenti climatici stanno contribuendo a questa espansione. Attualmente, la superficie forestale dell'UE ammonta a poco meno di 160 milioni di ettari, circa il 40% del territorio complessivo (il coefficiente di boscosità italiano è di poco inferiore).
Analoga crescita ha riguardato il volume legnoso delle foreste europee, con un aumento che nell'ultimo trentennio è stato di circa l'1% all’anno. In sintesi, dal secondo dopoguerra, i boschi europei hanno registrato non solo un’espansione della loro superficie, ma anche un significativo incremento della biomassa per unità di superficie (attualmente, circa 170 metri cubi per ettaro; un valore simile caratterizza le foreste del nostro paese) con conseguente miglioramento della qualità ambientale complessiva. Sebbene i boschi coetanei continuino a predominare, coprendo circa il 70% della superficie forestale, si osserva una crescente diffusione di quelli disetanei e di quelli multispecifici. Parallelamente, una vasta porzione degli ecosistemi forestali è stata progressivamente inclusa in aree destinate alla conservazione della natura (in Italia, oltre il 20% in termini di superficie).
In media, nelle foreste europee viene utilizzato circa il 70% dell'incremento annuale di volume legnoso. La produzione di tondame da lavoro proviene principalmente dai paesi dell'Europa centro-settentrionale, con la Germania, la Svezia, la Francia e la Finlandia tra i principali produttori. Sono in corso significativi cambiamenti strutturali nei mercati dei prodotti derivati dal legno: se da un lato il consumo di alcuni prodotti, come la carta, è in diminuzione, dall'altro si registrano tendenze stabili o in crescita per altri tipi di prodotti. Stanno emergendo nuove categorie, in particolare una vasta gamma di prodotti in legno ingegnerizzato e fibre cellulosiche artificiali, destinate a sostituire fibre meno sostenibili, come il cotone e quelle derivate dal petrolio, oltre a prodotti chimici a base di legno, prodotti nelle cosiddette bioraffinerie. Queste innovazioni stanno determinando un cambiamento nella domanda di legname, con una crescente preferenza per assortimenti di dimensioni più piccole, a discapito di quelli di maggiori dimensioni.
L'offerta di legname e il commercio internazionale sono stati recentemente influenzati da eventi climatici estremi, come la tempesta Vaia in Italia, e da fattori esterni al settore forestale, tra cui la guerra in Ucraina che ha determinato una drastica riduzione delle esportazioni da questo paese, oltre alle sanzioni imposte a Russia e Bielorussia, con un impatto rilevante sia sui prezzi che sulla disponibilità di legname. Di conseguenza, il mercato europeo sta cercando di rafforzare la propria autosufficienza, processo che però richiede tempo e investimenti. Esempio paradigmatico è rappresentato dalla situazione in Italia, dove il settore manifatturiero del legno, in particolare quello dell'arredamento, gioca un ruolo significativo, orientato verso l'export di alta qualità (made in Italy). A fronte di un fabbisogno nazionale di circa 50 milioni di metri cubi di materiale legnoso all’anno, il prelievo nazionale di legno si limita a circa 15 milioni di metri cubi, di cui quasi 11 milioni destinati a impieghi energetici. Questo prelievo corrisponde a meno del 40% dell'accrescimento naturale annuale di massa legnosa delle foreste e piantagioni da legno italiane. Persistono, dunque, rilevanti motivazioni e margini significativi per un incremento calibrato dell'approvvigionamento di biorisorse legnose su base nazionale nel nostro paese, che deve però avvenire nel contesto di una pianificazione forestale puntuale, attraverso una selvicoltura razionale e seguendo un approccio “a cascata” (ovvero l'impiego del legno in diverse fasi: inizialmente come materia prima e materiale da costruzione e per arredamento, anche riciclato, e solo nell'ultima fase per la produzione di energia).
È evidente che questa transizione può avvenire solo in una prospettiva di lungo periodo e tenendo in conto la multifunzionalità delle risorse forestali. In Europa, la maggior parte dei boschi tecnicamente maturi per l’utilizzazione è di tipo coetaneo e ha avuto origine molti decenni fa, attraverso rinnovazione sia artificiale che naturale. Nel corso di questo periodo, gli atteggiamenti sociali nei confronti delle foreste, così come le richieste di utilità ecosistemiche, hanno subito cambiamenti radicali. Essendo intrinsecamente legata allo sviluppo a lungo termine dei popolamenti forestali, la gestione forestale non può rispondere immediatamente a questi mutamenti e le misure di gestione devono essere, appunto, guidate da una visione di lungo periodo.
Il raggiungimento di un ampio consenso sui valori e sugli obiettivi di questa visione, unito alla disponibilità a individuare soluzioni condivise, è condizione imprescindibile per azioni efficaci e dinamiche a fronte delle numerose sfide della gestione forestale in Europa: a tal fine, sarebbe perciò necessaria una politica comune a livello unionale. Peraltro, le prospettive non appaiono particolarmente incoraggianti, come dimostra l’attuale stallo nella finalizzazione della proposta di Regolamento UE per l’istituzione di un quadro di monitoraggio delle foreste, a oltre un anno e mezzo dalla sua presentazione da parte della Commissione Europea.