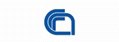Dati satellitari e agricoltura di precisione: il futuro dell’innovazione sul campo
di Simone Orlandini, Michele Pisante, Marco Vieri
- 26 March 2025
Ultimi inserimenti
- Una rassegna floreale per far rivivere un antico giardino botanico
- Profitti e costi fisiologici delle resistenze nelle piante
- Non buttiamo via le bucce di cipolla: nella dieta delle bovine da latte ne riducono la metanogenesi enterica
- Evo 2: l'IA che legge i genomi e definisce il futuro delle coltivazioni
- Dialoghi sul Verde: “Verde urbano e salute umana”
L’uso dei dati satellitari sta trasformando rapidamente l’agricoltura di precisione, offrendo agli agricoltori una conoscenza dettagliata dei propri sistemi colturali e aziendali, permettendo loro di ottimizzare le decisioni strategiche. Se un tempo questa tecnologia era confinata alla ricerca, oggi notevoli sforzi sono profusi per renderla accessibile in applicazioni dirette sul campo. Tuttavia, per sfruttarne appieno il potenziale, è necessario affrontare alcune sfide legate alla diversità delle condizioni agronomiche, pedoclimatiche e tecniche. In particolare, è fondamentale favorire un dialogo efficace tra fornitori di dati e operatori del settore, affinché queste innovazioni si traducano in strumenti realmente utili. Il trasferimento tecnologico rappresenta un ruolo chiave in questo processo, consentendo agli agricoltori di incrementare la produttività, ridurre i costi e minimizzare l’impatto ambientale.
L’agricoltura moderna sfrutta l’interconnessione tra telerilevamento, meccanizzazione e ingegneria avanzata per raccogliere e analizzare dati digitali auspicabilmente interoperabili, essenziali per la gestione agronomica di precisione. I dati satellitari permettono, attraverso l’aumentata capacità di calcolo, di monitorare e valutare la gestione dei processi produttivi, per verificare l’impatto ed i benefici in tempo reale, rispetto a predeterminati indicatori di risultato, l’erosione idrica ed il contenuto di carbonio organico del suolo. Inoltre, le più recenti tecniche di analisi multi-temporale offrono un’alternativa efficace ai convenzionali metodi di mappatura geospaziale, consentendo di ottimizzare il posizionamento dei punti di campionamento e riducendo significativamente tempi e costi.
Con il crescente utilizzo delle immagini satellitari, diventa sempre più cruciale affinare le competenze scientifiche e professionali per interpretare correttamente le variazioni colturali e individuare tempestivamente l’insorgenza di stress biotici e abiotici, fenomeni amplificati dai cambiamenti climatici. Un’analisi accurata su scale spaziali e spettrali diverse consente di programmare interventi mirati, limitando l’impatto negativo sulle colture.
L’agricoltura di precisione è un sistema complesso in cui diverse tecnologie devono essere integrate in modo efficace per ottenere risultati concreti. In questo scenario, il linguaggio digitale funge da ponte tra strumenti tecnologici, dati raccolti, processi analitici e operatori del settore. Sebbene l’automazione e la robotica stiano acquisendo un ruolo sempre più centrale, l’intervento umano resta imprescindibile per prendere decisioni strategiche basate sull’analisi dei dati. Comprendere la variabilità dei sistemi agricoli permette non solo di anticipare le criticità, ma anche di valutare con maggiore precisione la qualità e la sostenibilità delle produzioni.
Le tecnologie spaziali rappresentano strumenti scalabili, adatti a realtà agricole di ogni dimensione. Tuttavia, il passaggio da un modello agricolo tradizionale a uno basato sull’analisi avanzata dei dati richiede un cambio di mentalità: occorre abbandonare un approccio uniforme alla coltivazione e adottare strategie più flessibili e personalizzate, supportate da sistemi di analisi multidimensionali.
L’innovazione nel settore agricolo si basa su quattro pilastri fondamentali:
1. comprendere il valore aggiunto delle nuove tecnologie;
2. selezionare strumenti affidabili e appropriati per le specifiche esigenze produttive:
3. investire nella modernizzazione delle infrastrutture aziendali e nella formazione del personale;
4. creare un ecosistema territoriale capace di sostenere l’adozione di innovazioni tecnologiche in formato digitale.
Al centro di questo processo c’è il capitale umano: solo attraverso una formazione adeguata sarà possibile integrare efficacemente le nuove tecnologie e affrontare con successo le sfide della digitalizzazione in agricoltura. Questo processo richiede la formazione di competenze trasversali fra gli attori competenti nei diversi domini (le tecnologie, le tecniche, la conoscenza particolare del sistema agricolo territoriale) evitando l’errore di focalizzarsi solamente su un servizio da vendere agli agricoltori.
Un esempio concreto di innovazione nel settore è il progetto IRIDE, una costellazione di satelliti per l’osservazione della Terra promossa dal governo italiano e finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Attualmente in fase di sviluppo, IRIDE è gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e sarà completato entro il 2026. Questo ambizioso progetto si distingue per il suo approccio innovativo: IRIDE è una "costellazione di costellazioni", composta da diversi gruppi di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), che rientrano nel Segmento Upstream, affiancati da infrastrutture operative a terra (Downstream) e da servizi dedicati alla Pubblica Amministrazione italiana (Service Segment). Il progetto prevede il lancio di satelliti dotati di sensori di ultima generazione, tra cui radar ad apertura sintetica (SAR), strumenti ottici ad alta e media risoluzione e sensori operanti in bande pancromatiche, multispettrali, iperspettrali e infrarosse. Oltre a fornire dati alla Pubblica Amministrazione, IRIDE sarà un prezioso alleato della Protezione Civile per la gestione del rischio idrogeologico e degli incendi boschivi, il monitoraggio delle infrastrutture critiche, della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche. Inoltre, il progetto favorirà lo sviluppo di nuove applicazioni commerciali, offrendo dati analitici a startup, piccole e medie imprese e aziende del settore industriale.
Per garantire un’integrazione efficace delle informazioni satellitari nell’agricoltura di precisione, è necessario, come già accennato, focalizzarsi su alcuni aspetti chiave:
• approfondire la conoscenza agronomica e biofisica dei complessi sistemi agricoli;
• sviluppare soluzioni tecnologiche su misura per le esigenze territoriali del settore;
• rafforzare la formazione e l’aggiornamento professionale dei professionisti che operano nel comparto.
Solo combinando innovazione tecnologica, competenze specialistiche e strategie mirate, sarà possibile modernizzare l’agricoltura, più efficiente, sostenibile e resiliente alle sfide future.