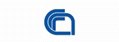Verso un nuovo sistema per la gestione del rischio in agricoltura
di Ermanno Comegna
- 05 February 2025
Ultimi inserimenti
- Adattamenti e specializzazioni degli insetti cavernicoli
- Ionomica e lipidomica per migliorare la nutrizione delle piante, l’esempio dell’olivo e dell’olio
- “Su Porceddu” di Sardegna verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica
- Il vino sbarca in Sicilia 6.000 anni fa
- Riforestazione urbana: soluzioni reali o propaganda verde?
Le azioni da mettere in campo per circoscrivere e tenere sotto controllo i rischi delle imprese agricole sono diventate una delle aree strategiche gestionali che maggiormente preoccupano gli imprenditori, per effetto della imprevedibilità e della variabilità dei fattori che incidono sui costi, sul rendimento produttivo e sui prezzi.
Le avversità climatiche che aumentano in frequenza ed intensità, la diffusione di malattie delle piante e del bestiame difficili da prevenire ed arginare, la volatilità dei prezzi, i fenomeni geopolitici che provocano turbolenze nei mercati sono alcuni degli esempi che si possono menzionare per evidenziare l’importanza che ha assunto il sistema della gestione del rischio.
Sono sempre più le imprese agricole che mettono in atto iniziative di prevenzione che vanno dalla semplice diversificazione degli ordinamenti produttivi, fino all’allestimento di costosi presidi per la difesa attiva delle colture, come sono ad esempio le reti antigrandine e gli impianti antibrina. Molti utilizzano i cosiddetti strumenti passivi che consistono nel trasferimento dei rischi a terzi (polizze assicurative) o nella condivisione dell’alea attraverso forme di mutualità.
Un ruolo importante è ricoperto dal sostegno pubblico che, con diverse modalità, incentiva le imprese agricole ad utilizzare strumenti per limitare l’incertezza. Le Regioni e le Province autonome - non tutte per la verità con la stessa convinzione e intensità - intervengono attraverso i loro complementi di programmazione per lo sviluppo rurale, finanziando gli investimenti per la prevenzione e quelli necessari per il ripristino delle condizioni produttive, dopo che l’evento avverso si è verificato ed ha prodotto i danni alle strutture, agli impianti e alle attrezzature.
Il Ministero opera da anni concedendo incentivi per le polizze assicurative, i fondi di mutualità danni, i fondi di mutualità reddito, ed in ultimo il fondo mutualistico nazionale per le avversità catastrofali (il cosiddetto Agricat a copertutas di eventi temibili come le alluvoni, la siccità e le gelate). Inoltre è sempre attivo, anche se con un’intensità inferiore rispetto al passato, il fondo di solidarietà nazionale, con la compensazione di danni di tipo sistemico che interessa un determinato territorio.
In pratica già oggi in Italia è in funzione un approccio composito per affrontare il tema dei rischi in agricoltura, ma come emerge in maniera sempre più evidente, c’è bisogno di rivedere, migliorare e completare il funzionamento, tenendo conto delle debolezze che si sono manifestate negli ultimi anni e delle necessità emergenti.
Le stesse istituzioni dell’Unione europea sono sensibili all’argomento. Non a caso, tra i punti qualificanti del programma da realizzare nel quinquennio 2024-2029 è stata inserita, sia dalla Commissione che dal Consiglio dei Ministri, l’esigenza di rafforzare il sistema della gestione del rischio. Un primo segnale dovrebbe materializzarsi nel documento di visione che il commissario Hansen presenterà entro il prossimo mese di marzo.
Intanto in Italia continua l’opera di manutenzione e aggiustamento degli strumenti disponibili, come emerge dalla lettura delle bozze del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025 (PGRA), sul quale il Ministero sta apportando gli ultimi ritocchi, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e completata la consultazione con gli organismi di rappresentanza del settore agricolo.
La spesa pubblica destinata a finanziare i quattro interventi (le polizze agevolate e i tre fondi mutualistici) ammonta a circa 700 milioni di euro l’anno, considerando anche le risorse del fondo di solidarietà nazionale e i trasferimenti dal regime dei pagamenti diretti che sono utilizzati come quota privata per il fondo Agricat. Si è raggiunto un livello mai visto in passato. A dispetto del consistente sforzo finanziario, le misure attivate risultano insufficienti per coprire la varietà e l’intensità degli eventi dannosi che periodicamente si verificano, come è attestato dai risultati del 2022 e del 2023, quando la spesa ammessa a contributo per le polizze agevolate è risultata superiore allo stanziamento disponibile. Di conseguenza, gli agricoltori beneficiari hanno ottenuto un’aliquota di contributo di poco superiore al 50%, rispetto al tasso del 70% stabilito come soglia massima concedibile dai regolamenti comunitari.
Non si riscontra solo un problema di risorse pubbliche, ma ci sono altri elementi critici da affrontare, come la necessità di fare in modo che il ricorso agli strumenti di gestione del rischio si diffonda in maniera omogenea a livello settoriale e territoriale. Vi è in aggiunta l’esigenza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli esistenti. Senza trascurare la ricerca della sinergia e della complementarietà tra i diversi strumenti; la lotta al malfunzionamento di alcune componenti del sistema (il Fondo Agricat è solo uno tra gli esempi che possono essere citati); la necessità di interventi strutturali per ridurre i costi di transazione.
L’equazione è complicata da risolvere, ma questo non deve frenare gli sforzi che le istituzioni e le imprese stanno producendo. L’idea di introdurre dal 2025 la polizza semplificata, a copertura delle avversità catastrofali, più altri eventi a scelta dell’agricoltore, rappresenta un serio tentativo di rispondere all’obiettivo di migliorare le prestazioni del sistema di gestione del rischio in Italia e favorire una più equilibrata diffusione delle coperture assicurative a livello geografico e settoriale.
Non c’è altra soluzione rispetto a quella di proseguire nell’approccio riformista sperimentato negli ultimi anni, promuovendo, con ulteriori innovazioni e pensando a nuove iniziative finalizzate all’efficace funzionamento delle strategie pubbliche e private per aumentare la resilienza delle aziende agricole nei confronti dei fattori esterni imprevedibili.