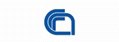In primo piano
“Dialoghi sul suolo e l’acqua”: Inquinamento del suolo, una minaccia subdola
Dialogo con Gianniantonio Petruzzelli, Dirigente di Ricerca del CNR.
Marcello Pagliai e Gianniantonio Petruzzelli 07 January 2026

Pagliai – Caro Gianni, intanto è bello ritrovarsi dopo 51 anni a parlare ancora di suolo e in particolare di inquinamento (proprio allora già studiavi i metalli pesanti!) e, nonostante i nostri studi e i numerosi allarmi della comunità scientifica, questo problema rappresenta, ora più che mai, una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana ma, come sottolinea la FAO ad esempio, si sa ancora troppo poco sulla portata di tale minaccia a livello globale. L’inquinamento del suolo, infatti, spesso non può essere percepito visivamente o direttamente valutato, rendendolo un pericolo nascosto dalle gravi conseguenze.
Petruzzelli – Caro Marcello hai ragione, l'inquinamento del suolo rappresenta ancora una problematica ambientale delle più importanti e delle più trascurate. A differenza di altri tipi di inquinamento, come quello dell’aria e dell’acqua il deterioramento del suolo spesso non è percepibile con l'olfatto, non è visibile a occhio nudo, ma i suoi effetti negativi possono manifestarsi e permanere per molti anni. Queste caratteristiche rendono l’inquinamento del suolo particolarmente pericoloso, soprattutto in ambito agricolo, dove la qualità del terreno è strettamente legata alla qualità degli alimenti e alla salute umana. Il legame tra suolo e salute è evidente: un terreno contaminato può trasferire questi inquinanti alle colture, e quindi agli animali da allevamento e all’uomo.
Pagliai – L’inquinamento influisce, infatti, sulla sicurezza alimentare sia compromettendo il metabolismo delle piante e riducendo così i raccolti, sia rendendo le colture non sicure per il consumo poiché elementi pericolosi come arsenico, piombo e cadmio o sostanze organiche come i policlorofenili, idrocarburi aromatici policiclici, possono entrare nella catena alimentare presentando gravi rischi per la salute umana. L’inquinamento del suolo colpisce quindi il cibo che consumiamo, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo e la salute dei nostri ecosistemi. La quasi totalità di tale inquinamento è dovuto alle attività antropiche, tuttavia, anche se la produzione industriale, l’urbanizzazione ecc., continuano a crescere a un ritmo rapido, non è mai stata effettuata una valutazione sistematica dello stato di inquinamento del suolo a livello mondiale.
Quando le foreste smettono di assorbire carbonio: il campanello d’allarme del clima
Francesco Ferrini 07 January 2026

L’articolo “Aboveground biomass in Australian tropical forests now a net carbon source” pubblicato qualche settimana fa su “Nature" analizza quasi cinquanta anni di dati (1971–2019) provenienti da foreste tropicali umide dell’Australia nord-orientale, tra gli ecosistemi terrestri più ricchi di biomassa al mondo. Tradizionalmente considerate importanti pozzi di carbonio, queste foreste hanno mostrato un cambiamento radicale nel loro bilancio del carbonio: dalla fine del XX secolo, la biomassa legnosa epigea è passata da un assorbimento netto di carbonio a una perdita netta verso l’atmosfera.
I risultati indicano che tra il periodo 1971–2000 le foreste funzionavano come pozzi di carbonio, con un assorbimento medio di circa 0,62 Mg C ha⁻¹ anno⁻¹, mentre nel decennio 2010–2019 si osserva una perdita netta di circa 0,93 Mg C ha⁻¹ anno⁻¹. Questo cambiamento non è attribuibile a una riduzione della crescita degli alberi, bensì a un forte aumento della mortalità arborea e delle perdite di biomassa, legate principalmente all’intensificazione delle anomalie climatiche. Temperature più elevate, aumento del deficit di pressione di vapore e stress idrico hanno accelerato la morte degli alberi, riducendo drasticamente il tempo di permanenza del carbonio nella biomassa forestale.
Notiziario
Prossimi eventi
"Bosco, Albero, Uomo" - Mostra fotografica
L’evoluzione dei paesaggi viticoli dall’antichità ad oggi
Luigi Bavaresco 07 January 2026

Con la domesticazione della vite (avvenuta circa 11.500 anni fa nell’area trans-caucasica e nel Levante) prendono forma i paesaggi viticoli, frutto del rapporto stabilitosi nel tempo tra le viti e gli uomini, la convivenza virtuosa tra di loro.
Alimenti ultratrasformati causa di malattie
Il pericolo deriva non da quello che contengono, ma da quello che questi alimenti semplificati non contengono ed è invece necessario per il nostro organismo.
Giovanni Ballarini 07 January 2026